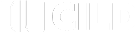Gjadër, poche decine di case nella campagna albanese, a meno di venti km dalla costa, è un centro abitato rimasto fino a oggi estraneo alla cronaca, noto solo per la presenza della base aerea dismessa nel 1993. Con la ratifica del Protocollo Italia-Albania, che prevede per l’Italia la possibilità di valutare le domande di protezione internazionale anche in territorio albanese, è diventato il luogo scelto per costruzione del Cpr, Centro di permanenza e rimpatrio per migranti, insieme a Shengjin dove è stato realizzato l’hotspot di “primo approdo”.
Questa collina ha così cominciato a trasformarsi sotto gli occhi degli abitanti, che oggi guardano una lunga e alta recinzione metallica dalla quale si scorgono le decine di container all’interno.
“È nato in poco tempo – spiega una donna che abita dall’altro lato della strada che separa le proprietà private dalla struttura – a noi nessuno ha chiesto niente, e tantomeno ci hanno riconosciuto un indennizzo per averci tolto la vista della campagna. Comunque non avremmo accettato nulla in ogni caso, non vogliamo avere a che fare con quanto avviene qui, vogliamo solo continuare la nostra vita. Sappiamo che dovrebbero collocarvi i cittadini stranieri, ma di fatto questo spazio è completamente vuoto, ci sono solo le forze di polizia che controllano e nessun altro.”
Ciò che pensa degli accordi con l’Italia non lo dice apertamente, ma ricorda che suo figlio, qualche anno fa, è stato un migrante, e quelli di oggi non saranno poi così diversi.
Nel frattempo, l’Italia si prepara per la terza volta a trasferire alcune delle persone soccorse in mare direttamente al porto di Shengjin: il pattugliatore militare Cassiopea, che ha già preso a bordo 11 cittadini fra egiziani e bengalesi , si trova al largo di Lampedusa in attesa di imbarcare altre persone che soddisferebbero i “criteri” per poter essere identificati in Albania.
La rotta balcanica
L’Albania rientra nella rotta migratoria dei Balcani occidentali, fra il confine meridionale e sud-orientale con la Grecia e verso il Montenegro e il Kosovo. Il rafforzamento dei controlli alla frontiera serba ha ulteriormente incrementato il transito nel paese: secondo i dati della Caritas locale, da ottobre 2018 ad aprile 2019, la polizia di frontiera ha identificato oltre 3.500 persone ai valichi di Gjirokastra e Korçë. Nel 2023 l’ingresso dei migranti è risultato essere strettamente legato alla situazione in Grecia: secondo i dati di Frontex, nel corso dell’anno sono state identificate circa 9 mila persone, che poi hanno scelto di proseguire lungo la rotta balcanica oppure di attraversare l’Adriatico e raggiungere le coste italiane con traghetti di linea o piccole imbarcazioni.
L’Albania è stata il primo paese che nel 2018 ha siglato un accordo con l’Agenzia europea per la guardia di frontiera e costiera, che ha dato il via ad un’azione congiunta dove il personale Frontex avesse poteri esecutivi sul suo territorio. Per monitorare gli arrivi, nel 2023 è stato aperto un centro di accoglienza temporaneo per migranti irregolari con il supporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).
La nascita dell’attivismo albanese
“L’Albania non è tipicamente un paese di destinazione dell’immigrazione, anche se dal 2019 è diventata parte importante della rotta balcanica – spiega Fioralba Duma, attivista italo-albanese – ed è da allora che l’opinione pubblica ha cominciato a interessarsi al tema. Uno dei primi campi di accoglienza realizzato si trova a Babrru, periferia residenziale di Tirana, e la nascita di questo luogo ha sconvolto la popolazione locale. Così i media hanno cominciato a parlarne, ma in Albania i mezzi di informazione sono legati al potere politico ed economico e non erano realmente preparati, quindi si è fatto tanto allarmismo. Dall’altra parte, anche le associazioni indipendenti che vogliono occuparsi di accoglienza o di altre questioni sociali non hanno vita facile, perché sono obbligate ad avere una sede propria, a pagare un affitto, ad avere almeno un dipendente. Facile immaginare come queste condizioni precludano a molte piccole organizzazioni di attivisti e volontari la possibilità di costituirsi formalmente: chi va avanti è perché riceve fondi europei o americani e si uniforma ai dettami istituzionali.”
Fioralba Duma racconta che l’attivismo sull’immigrazione è nato in modo spontaneo, dal basso, dagli abitanti delle zone di transito che offrivano viveri ai migranti, dagli escursionisti che frequentano i sentieri di montagna, dalle chiese e dalle moschee. “Quello che risulta difficile è sempre dare dei numeri per inquadrare il fenomeno migratorio e del transito via Albania, perché oltre ad esserci molti punti di passaggio, non ci sono percorsi di accoglienza strutturati”.
Il tema è diventato oggetto di dibattito pubblico solo con la firma del Protocollo Italia-Albania, il 6 novembre 2023, anche se le informazioni sono arrivate più dai media italiani che da quelli locali. E ancora una volta l’idea emersa fra chi segue la questione migratoria e della militarizzazione e controllo delle frontiere è che l’Albania sia stata utilizzata come “hotspot” per conto terzi, piuttosto che essere parte di un’intesa paritaria.
“Qui in Albania abbiamo un precedente a riguardo – continua Duma – perché in virtù di un accordo con gli Stati Uniti, da oltre dieci anni, il nostro paese ospita circa tremila dissidenti iraniani, membri del Mek, Mojahedin-e Khalq, o Esercito di liberazione nazionale dell’Iran. E pensare che qui non abbiamo nemmeno un’ambasciata dell’Iran. Un altro esempio ben più noto è quello dei cittadini afghani che nel 2021, dopo la ripresa del potere dei Talebani, sono stati fatti evacuare dal paese perché avevano collaborato con gli Usa, e ora vivono a Shengjin, al Raffaelo Resort, in attesa dei documenti per potersi trasferire in America o in Europa. Anche in quel caso la gente del posto li ha accolti con diffidenza, per poi rendersi conto che erano tutte paure infondate. Ma resta il fatto che dell’Albania si “dispone” in molti modi, con un approccio che può essere definito coloniale. Infine abbiamo accolto migliaia di cittadini ucraini, senza accordi specifici. Insomma, la questione migratoria ci ha coinvolto attraverso diverse crisi.”
L’adesione all’Ue
L’Albania ha presentato domanda di adesione all’Unione Europea nel 2009, e l’anno dopo la Commissione Europea ha valutato che il paese dovesse ancora lavorare per raggiungere il livello di conformità ai criteri richiesti per l’ingresso, come il completamento del riordino della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia, il rafforzamento della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Nel 2014 è stato concesso lo status di paese candidato, e quattro anni dopo, il Consiglio ha riconosciuto i progressi dell’Albania, seppure da consolidare, come precondizione per aprire i negoziati di adesione, accordati nel 2020.
“Dalle dichiarazioni pubbliche politico-istituzionali l’Albania è pronta per entrare nell’Unione Europea – dice l’attivista Besmir Skëndaj – ma se consideriamo gli standard di accoglienza siamo molto indietro. La collaborazione con Frontex serve ad affrontare soprattutto gli ingressi dei cittadini albanesi che tornano a casa, ma non quella di chi arriva da altri luoghi e attraversa il paese senza passare da nessun varco ufficiale, per poi spostarsi in Montenegro verso l’Ue. Siamo considerati un punto di transito, ma nessuno dice che quando entreremo a far parte dell’Unione Europea la situazione cambierà: a quel punto l’Albania diventerebbe paese di primo approdo e dovrebbe gestire identificazioni e richieste di protezione internazionale. Gli albanesi che vivono in Albania hanno il miraggio dell’Europa, vogliono a tutti i costi entrare nell’Unione. Gli albanesi della diaspora, che vivono in Italia, in Grecia o in altri paesi europei, sono certamente più disillusi, perché chiedono prima il raggiungimento di alcuni standard da rispettare, e bisogna tenere conto che un paese con meno di tre milioni di abitanti non avrebbe comunque alcun potere decisionale, anche dentro all’Unione, perché questa Europa non lascia spazio ai paesi meno sviluppati. Il messaggio che lancia la costruzione di un hotspot come quello di Shengjin, o di un Cpr come quello di Gjadër, gestiti per conto terzi, fa pensare al modello della discarica, non a quello dell’accoglienza.”
Il Kareç Detention Centre
Proprio in fatto di standard europei nell’accoglienza, il Kareç Detention Centre che si trova vicino a Durazzo, e che meno di un mese fa ha registrato la fuga di 11 persone dal suo interno, ha attirato l’attenzione del Comitato Europeo per la Prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Aperto nel 2010 vicino a Durazzo, può ospitare fino a 125 persone, anche se i numeri dei trattenuti sono sempre stati inferiori. Il massimo è stato raggiunto nel 2018 con 80 cittadini stranieri. Dalle visite effettuate all’interno, l’ultima nel 2023, e dalle testimonianze raccolte fra coloro che vi hanno trascorso un periodo di detenzione amministrativa, è emersa una quasi totale assenza di informazioni nei confronti dei trattenuti, principalmente a causa delle barriere linguistiche e dell’impossibilità di essere affiancati da un avvocato. Gli ex trattenuti hanno anche riferito di condizioni igieniche precarie, di assenza di attività all’interno e della grande difficoltà di poter comunicare con i familiari, data l’impossibilità di avere con sé un telefono. Come riferito anche dal Comitato, dalla consultazione dei singoli fascicoli amministrativi dei reclusi presenti al momento della visita, non è emersa nessuna indicazione sulle motivazioni né sul periodo di detenzione, e la maggior parte dei cittadini stranieri presenti ammetteva di aver firmato documenti senza conoscerne il contenuto.
Il lavoro del Difensore civico
Secondo l’ultimo report del 2024 rilasciato dal Border Violence Monitoring Network (BVMN), una rete di ong e associazioni che operano in Grecia e nei Balcani, il Primo Ministro albanese Edi Rama ha fatto leva sui sentimenti dei connazionali e sul loro senso comune di “nazione di migranti” per giustificare il coinvolgimento nell’accordo con l’Italia. BVMN ha parlato di una sorta di ricatto legata proprio alla richiesta di adesione all’Ue, dove viene offerta assistenza in cambio di un aiuto nel rafforzamento dei confini europei e di una conseguente riduzione del numero di persone che possono varcarli.
Anche il Difensore civico albanese, Avokati i Popullit, ha espresso sin dall’inizio delle perplessità sull’accordo, prima delle sentenze dei tribunali italiani. Istituito nel 2009, allo scopo di difendere i cittadini da atti illegittimi della pubblica amministrazione, opera solitamente sulla base di un reclamo presentato al suo ufficio, anche se può decidere di propria iniziativa di occuparsi di un determinato caso. L’organismo non ha però il potere di ristabilire i diritti negati o gli interessi lesi, ma propone raccomandazioni per porre rimedio alle violazioni, mediando fra le istituzioni e l’individuo coinvolti. Nel caso del trattenimento dei migranti nei Cpr, che rientra nella sezione di competenza del Meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura (NPM), si è sollevata l’ipotesi di illegittimità del trasferimento e della permanenza dei migranti in condizioni di privazione della libertà personale.
L’inizio delle proteste e la nascita del Network Against Migrant Detention
“Le proteste contro il Protocollo Italia-Albania sono iniziate a Leshe, da parte dei cittadini che non volevano i centri per i migranti non perché contrari ai diritti umani, ma per timore di problemi sul proprio territorio – racconta Clara Osma, anche lei attivista italo-albanese – ma nel corso dell’ultimo anno gli attivisti albanesi che vivono in Albania e all’estero, insieme a quelli italiani ed europei, hanno cominciato a ragionare sulla costituzione di un movimento transnazionale contro la detenzione amministrativa e la deportazione delle persone migranti. Così il 6 novembre 2024 è stato presentato in conferenza stampa il Network Against Migrant Detention, che ha subito lanciato una mobilitazione collettiva in Albania che si è svolta l’1 e il 2 dicembre, a Gjadër, Shengjin e Tirana.”
“Creare un’alleanza italo-albanese per contrastare un modello europeo è stato fondamentale – ricorda Detjon Begaj, nato in Albania e oggi consigliere comunale a Bologna – chi ha vissuto l’emigrazione come molte famiglie albanesi sa quanto sia difficile ottenere i propri diritti in un altro paese; i nostri genitori sono stati vittime di razzismo in Italia, e oggi viene nuovamente rafforzata un’idea di sottomissione venduta come amicizia, che va contrastata fermamente.”
“Noi albanesi ci siamo spostati in Italia, in Grecia, in Germania, negli Usa, e non siamo stati subito accettati, anzi, ma col passare del tempo siamo diventati una ricchezza – spiega Ardit Minarolli studente di giurisprudenza e presidente di Volt Albania – l’attivismo nel nostro paese è un fenomeno recente, perché le persone si scontrano con un alto tasso di povertà, con la paura di non arrivare alla fine del mese, con la corruzione e la disillusione nei confronti della politica. Per questo occuparsi dei diritti degli altri è tutt’altro che semplice, ma l’interesse sta crescendo, e anche la partecipazione.”
“La comunità albanese è rimasta divisa perché per alcuni non è giusto imprigionare in Albania altri bisognosi, sul modello della Libia e dell’Uganda, usate come pattumiere umane – dice l’avvocato Gentian Alimadhi – mentre per altri la costruzione dei centri faceva pensare ad un’opportunità di sviluppo. Fortunatamente ormai esiste una società civile fatta da giovanissimi, sostenuti anche da organizzazioni internazionali, che protestano ogni qualvolta si verificano violazioni dei diritti, che si tratti di questioni ambientali o di leggi ingiuste. E questo è successo anche nel caso dell’apertura dei Cpr in Albania.”
L’avvocato Alimadhi fa parte degli albanesi all’estero della nuova generazione che si stanno spendendo per garantire il voto alla diaspora, in vista delle prossime elezioni. “Oggi questo diritto è garantito dal codice elettorale albanese – spiega – il prossimo passo è quello della tutela del voto dalla consolidata tendenza ai brogli che da sempre caratterizza il processo elettorale in Albania, oltre alla soluzione delle diverse problematiche tecniche che sicuramente impediranno la partecipazione a buona parte dei cittadini che vivono in altri paesi.”
Immagine di copertina di Ilaria Romano