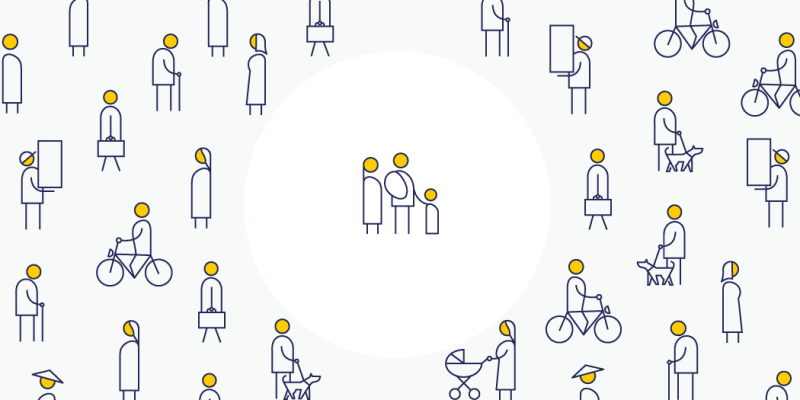È possibile misurare il livello di qualità dell’integrazione che uno stato membro della Ue può garantire a chi ha ottenuto asilo? E con quali parametri si valuta? I ricercatori di 15 paesi dell’Unione (14 più la Turchia) ci stanno provando con il progetto Niem, che sta per National Integration Evaluation Mechanism (Meccanismo di Valutazione dell’Integrazione Nazionale): una ricerca transnazionale, la più grande mai lanciata in Europa, della durata prevista di sei anni, che punta a indagare e rafforzare gli strumenti dell’integrazione, partendo dal presupposto che un beneficiario di protezione internazionale in media non tornerà nel proprio paese d’origine almeno per 17 anni, soprattutto se è fuggito da una guerra civile.
La ricerca si rivolge all’ambiente accademico come a quello della pubblica amministrazione, ai decisori come alle Ong, e anche agli stessi beneficiari di protezione internazionale, con l’idea di coinvolgerli di più man mano che il lavoro procede. Con due report previsti nell’arco dei sei anni e più di 150 indicatori individuati e fra loro interdipendenti, il progetto Niem dovrebbe fornire alcuni robusti strumenti per misurare la distanza tra normativa ed esperienza, individuare lacune e buone pratiche e valutare anche gli effetti dei numerosi cambiamenti legislativi, soprattutto di quelli che avvengono nei singoli stati membri. I risultati della ricerca si potranno vedere sul portale Niem.
I paesi partecipanti, Italia compresa
L’Italia è proprio uno dei paesi dove rafforzare i processi di integrazione si è fatto più necessario negli ultimi anni. La ricercatrice Marina D’Odorico è project manager per la Fondazione ISMU, il partner italiano nel progetto. Ci racconta che nei primi mesi, con la Polonia capofila del progetto con il suo Institute of Public Affairs, il progetto Niem ha perduto come partner il Regno Unito: dopo l’esito del referendum su Brexit i ricercatori non se la sentivano di assumersi un impegno a lungo termine nella cornice dell’Unione Europea. Al suo posto, però, è entrata la Grecia (con l’Antigone Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence), un altro dei paesi che hanno assorbito l’impatto più forte dell’immigrazione negli ultimi tre anni.
Fra Polonia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna, Lettonia, Francia, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca, Portogallo e Svezia, a cui si aggiunge una rappresentanza dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, spicca però l’assenza della Germania, forse lo stato Ue più organizzato nelle prassi per l’integrazione: “in realtà”, dice D’Odorico, “in queste ricerche transnazionali la Germania manca spesso, per un motivo preciso: essendo abituati a misurare tutto in termini di länder, e non di territorio nazionale, hanno difficoltà a comparare politiche nazionali”.
Fra i soggetti coinvolti nella ricerca, che si riuniscono per Niem in cosiddette “coalizioni nazionali” con l’aspirazione a raggiungere standard europei comuni, ci sono realtà più orientate alla ricerca e altre che operano proprio sul territorio, a stretto contatto con i beneficiari di protezione internazionale, come France Terre d’Asile in Francia. Open Migration ha preso parte a uno dei primi tavoli della coalizione nazionale italiana, ed è stato interessante vedere confrontarsi le esperienze di educatori e ricercatori, medici ed etnopsichiatri, intenti a creare nuovi e più sofisticati parametri per misurare un ipotetico ideale di integrazione e la sua applicazione concreta nella realtà. Il dialogo tra settori diversi – dalla scuola alla sanità – è apparso da subito come uno dei valori aggiunti del progetto.

In occasione dell’ultima Giornata Mondiale del Rifugiato, Karolina Grot, ricercatrice del polacco Institute of Public Affairs, ha sottolineato che un’integrazione efficace non può prescindere dalla collaborazione fra istituzioni, e tra queste e le comunità dei rifugiati. Si tratta in gran parte, ha detto, di rovesciare il discorso: “accade spesso che scarichiamo il peso delle responsabilità del successo del processo di integrazione unicamente sui rifugiati, introducendo adempimenti eccessivi e diversi ostacoli. Talvolta dimentichiamo che l’integrazione è un processo bilaterale, che richiede comprensione reciproca e un continuo dialogo tra gli attori coinvolti”.
Dalla prima accoglienza alla partecipazione sociale
Accesso ai servizi, alla scuola, al lavoro, recepimento delle normative in vigore, accesso agli uffici pubblici, lingua, diritti. Tante delle questioni che il progetto Niem cerca di identificare sono misurabili, altre appartengono invece a sfere, come il benessere psichico e affettivo, a cui ci si può soltanto avvicinare per vie indirette. Per esempio, suggerisce Marina D’Odorico, sappiamo che negli stati membri della Ue in cui è possibile o facilitato il ricongiungimento familiare, l’integrazione di chi ha ottenuto protezione internazionale ne ricava naturalmente beneficio.
Una delle prime questioni da misurare è sicuramente l’impatto che l’esperienza della prima accoglienza ha avuto sul richiedente asilo, perché spesso questa influenzerà il suo livello di integrazione quando questi otterrà la protezione internazionale. Questo dato appartiene alla primissima area di ricerca, quella che Niem chiama Condizioni generali. Esiste poi un’area individuata come Integrazione legale (residenza, unità familiare e riunificazione, accesso alla nazionalità effettiva). La successiva è l’Integrazione socio-economica (casa, impiego, addestramento vocazionale e istruzione collegata all’impiego; salute; previdenza sociale e assistenza pubblica). E infine, l’Integrazione socio-culturale (istruzione dei bambini, apprendimento della lingua e orientamento sociale, costruzione di ponti e stimolo alla partecipazione).
In questa sequenza, dall’impatto della prima accoglienza alla “costruzione di ponti”, è facile intuire che il fine ultimo e più alto di una buona integrazione è che i beneficiari di protezione internazionale arrivino a partecipare attivamente alla vita della società in cui sono inseriti.
Per alcuni paesi, anche quelli più all’avanguardia, si tratterà di individuare le aree dove l’integrazione lascia a desiderare – per esempio, l’Università di Malmo ha già stabilito, nella propria valutazione iniziale, che se da una parte in Svezia l’integrazione nel lavoro funziona bene, non si può dire altrettanto per l’accesso alla salute.

Foto via Pixia (CC 0).
Se il traguardo del progetto Niem è quello di scattare una fotografia dello stato dell’arte in un momento in cui le sfide dell’integrazione in Europa sono molto complesse – circondate come sono anche da narrazioni pubbliche che possono influenzare il risultato – i ricercatori non escludono di poter in qualche modo a loro volta influenzare le politiche. Misurare invece quanto sia aperta all’integrazione la società che riceve i rifugiati è più complesso: “se si chiede alle persone cosa pensano, risultano più aperte di quanto siano nella realtà; basta pensare alla tolleranza espressa a parole per i Rom, che però cambia quando c’è magari un campo rom vicino a casa”, dice D’Odorico.
Il quadro legale di partenza e l’apertura di aree di ricerca
Il progetto Niem non parte dal nulla, ma piuttosto sale sulle spalle di alcuni criteri preesistenti di misurazione dell’integrazione, una cornice legale che è stata per molto tempo relativamente stabile e oggi è in balia di continue modifiche legislative, di cui Niem tiene traccia qui. La base legale non consiste soltanto nelle direttive e nelle procedure nate dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ma anche nei Common Basic Principles, “undici criteri che appartengono in qualche modo alla ‘soft law’”, spiega D’Odorico. Niem parte da lì per raffinare e migliorare i criteri di misurazione, “ma alla fine quello che è veramente importante è quanto sono ricettive le istituzioni: si tratta di uno strumento valido solo se non c’è un muro nella politica o nella società”. Niem cerca di mappare l’esperienza preesistente di ricercatori e attori della società civile, e dove non dovessero esserci dati reperibili, dice D’Odorico, “il progetto potrà stimolare l’apertura di nuove aree di ricerca”.
L’impatto di queste ricerche sui beneficiari di protezione internazionale sarà ancora più lento da raggiungere di quello sulla politica e sulle amministrazioni: “loro vedranno i risultati molto più in là. [Migliorare] l’integrazione è un processo lungo e frustrante, e di questa lentezza i rifugiati soffrono molto”, dice D’Odorico. Sull’opinione pubblica, invece, il progetto Niem conta di influire soprattutto portando elementi concreti là dove ci sono dubbi e perplessità, o vuoti di informazione.
Una società migliore per tutti, non solo per i rifugiati
Uno dei punti cruciali della ricerca è la misurazione del livello di accesso alla salute, agli ospedali, e alla salute psichica, che spesso passa per prima cosa dalla traduzione attenta dalla lingua d’origine, ma altrettanto spesso da altre differenze culturali di cui l’etnopsichiatria si sta occupando da decenni, a volte inascoltata. Non in tutti i paesi c’è questo tipo di attenzione, e non sempre, anche quando è in vigore una buona normativa, il personale nelle strutture sanitarie dispone davvero delle risorse necessarie.
“Spesso fra quello che prevede la normativa e la sua attuazione concreta c’è una distanza”, dice D’Odorico, “che è proprio fra le cose che noi ci proponiamo di misurare”. Inevitabile, lavorando sui singoli indicatori Niem, confrontarsi con la loro interpretazione nel quadro di welfare dei singoli paesi. In pratica, i 15 paesi partecipanti lavorano per soppesare e rafforzare politiche concordate a livello europeo, ma per farlo devono indagare, attraverso tutte le componenti della società civile di ciascun paese, le profonde differenze che corrono fra i diversi Pil nazionali, i vari sistemi di welfare, i rispettivi livelli di occupazione e la concezione stessa dell’istruzione, dei servizi, della burocrazia amministrativa e dello spazio pubblico.
Intanto, già dalla fisionomia degli indicatori che Niem studierà emerge con chiarezza che un potenziamento delle risorse per i migranti spesso equivale a un generale miglioramento dei servizi per tutta la popolazione autoctona, comprese le sue componenti più fragili. Si può dire che un paese in grado di offrire ai propri cittadini buoni livelli di welfare e assistenza è anche più in grado di ricevere immigrati e rifugiati e di integrarli nel proprio sistema, ma è vero anche il viceversa: “Sì”, conferma Marina D’Odorico, “si può dire che maggiore è la qualità dell’accoglienza di un paese per i migranti, maggiore è anche la qualità dei servizi per tutta la sua popolazione. Studiando quanto una società effettivamente garantisce pari diritti alle persone accolte, si individua una società di un certo tipo piuttosto che di un altro”.
Foto di copertina via Niem.
Disclaimer: Niem è cofinanziata da Open Society Foundations (che è anche tra i finanziatori di Open Migration).