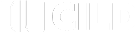Lisa e i suoi compagni sono appena rientrati in classe dopo l’allarme. Hanno trascorso l’ultimo quarto d’ora nello scantinato della scuola, il liceo artistico di Dnipro, ormai ben attrezzato con banchi, sedie, lavagne e per oggi anche spartiti musicali per la lezione di canto. Per questi ragazzi fra i 14 e i 19 anni, la sirena che avvisa il pericolo di un attacco imminente dal cielo è diventata parte della propria giornata scolastica, e in questi tre anni hanno imparato a conviverci. La madre di Lina l’ha appena chiamata al telefono per sapere dove fosse, perché questa volta un missile è arrivato a poche centinaia di metri da casa loro.
“Io lo so che potrei morire da un momento all’altro, però so anche che un vero modo per essere sicuri, qui in città, non c’è – dice questa adolescente con i capelli verdi e i jeans larghi – nessuno di noi può indovinare se sia meglio trovarsi all’aperto, in un parco, oppure a scuola, o a casa. La verità è che è impossibile prevedere esattamente cosa cadrà e dove, abbiamo solo l’App che ci dà l’allarme anche se a volte è un po’ lenta.”
Lisa frequenta il primo anno, ama il canto, la storia e la poesia, e racconta che ha paura che i russi insieme ai territori occupati si portino via tutta la cultura ucraina, perché vogliono cancellarne l’identità.
Dall’inizio della guerra sono sempre di più i giovani che, come Lisa, parlavano quasi esclusivamente russo e ora si impegnano nello studio dell’ucraino, soprattutto nell’Est del paese. Una sorta di resistenza culturale che oggi passa anche dalla lingua.
“Prima ognuno parlava come preferiva – spiega Olena, insegnante di comunicazione di Lisa – nessuno veniva definito in base alla lingua in cui si esprimeva, ma oggi il conflitto ha comprensibilmente alimentato il nazionalismo in tutte le sue forme, e anche rivendicare la propria lingua è diventato un gesto di orgoglio.”
Originaria di Dnipro, Olena ha alle spalle molti anni da reporter, e ha viaggiato in tutto il paese per lavoro. Quando è scoppiata la guerra ha seguito l’invasione giorno per giorno, ma non ha mai pensato che si sarebbe risolto tutto in un mese, come credeva la Russia. “Sarebbe finita se l’Ucraina si fosse arresa subito, ma come potevano pensarlo? – dice – Ora sta diventando un massacro, ognuno di noi è coinvolto in questa guerra. E dal fronte in molti dicono che allo stato attuale non abbiamo speranza di vincere. Eppure andiamo avanti. Io mi sono allontanata dalla mia città ma poi ho pensato che se ce ne fossimo andati tutti avremmo solo lasciato campo libero alla distruzione e a chi ci vuole sotto occupazione. Così ho fatto domanda di insegnamento, e questo è il mio primo anno da professoressa di liceo. Nella nostra scuola cerchiamo di trasmettere che anche la cultura e le forme d’arte sono resistenza, e che non bisogna avere paura di quello che potrebbe accadere perché la vita deve andare avanti.”
Orgogliosa della sua città, con le sue pietre antiche, i suoi ponti, la sua metropolitana mai completata, e la bandiera ucraina più alta e più grande del paese, Olena ha costruito una rete di relazioni molto fitta, che mette insieme studenti, organizzazioni umanitarie, realtà religiose e laiche che ogni giorno continuano a gestire i pasti e la ricerca di alloggi per gli sfollati, gli aiuti al fronte, gli eventi culturali e lo studio.
Il suo amico Yura, ad esempio, è tra i responsabili dell’associazione Food for Life Dnipro, un’organizzazione di volontariato internazionale che in Ucraina opera in tutte le principali città.
“I fondatori sono Hare Khrisna, della tradizione indù Vaishnava, ed è per questo che i pasti che prepariamo sono rigorosamente vegetariani – racconta Yura – ogni giorno si cucinano, si confezionano e si distribuiscono a chi ha più bisogno. Parliamo di circa un migliaio di porzioni al giorno. Ci sono posti di ritrovo fissi e altri mobili allestiti in caso di necessità, come è successo negli ultimi giorni con gli attacchi più pesanti, quando le persone hanno avuto bisogno di evacuare alcuni palazzi, essere portate in ospedale, assistite o anche solo confortate.
“Abbiamo trascorso tutto l’inverno a presidiare le zone più colpite dalla guerra, in città e anche nei villaggi vicini – ricorda Yura – cerchiamo di esserci tutti i giorni, perché purtroppo dopo i primi tempi di entusiasmo e di solidarietà le donazioni sono diventate sempre meno, e anche l’interesse internazionale è diminuito. La guerra qui non fa più notizia, anzi, alcuni miei conoscenti che si trovano in Europa pensano che la situazione si stia stabilizzando, quando invece è ancora molto pericoloso per i civili, che vivono una situazione di grande fragilità. Anche chi all’inizio ha retto il colpo, pian piano sta perdendo le speranze per il futuro, si sente in una vita sospesa, in molti casi ha perso tutto e non crede di avere alcuna possibilità di ricominciare. La continua minaccia di essere un bersaglio umano sta minando anche la salute mentale delle persone, e più il tempo passa più la situazione si aggrava”.
Proprio per la vicinanza alla prima linea, la regione di Dnipro ha il più alto numero di sfollati interni di tutto il paese, almeno 520 mila persone, e nel corso dell’ultimo anno ha registrato anche 257 mila rientri di persone che nei primi due anni di guerra si erano spostate ad Ovest o avevano lasciato l’Ucraina.
Secondo i dati raccolti dall’ong svizzera Impact, i rientri nelle aree entro i 30 km dal fronte costituiscono circa un terzo dei ritorni complessivi di sfollati interni dal febbraio 2022 ad oggi (circa 1.6 milioni di persone). In particolare, nei primi sei mesi del 2024, nonostante il peggioramento delle condizioni di sicurezza, i ritorni nei pressi della “front line” sono stati l’11% del totale. Le motivazioni sono diverse, e includono l’erosione delle risorse disponibili per sostenersi altrove, ma anche il bisogno emotivo di tornare da persone e luoghi familiari indipendentemente dal rischio che si corre. Le famiglie di sfollati interni e quelle rientrate dall’estero sono state classificate come aventi bisogni umanitari superiori del 25% rispetto a quelle non sfollate.
“Dnipro è la più grande città ucraina vicina al fronte e di conseguenza è diventata lo snodo fondamentale dello smistamento degli aiuti, dell’arrivo degli sfollati, del coordinamento delle attività di supporto ai civili direttamente colpiti dalla guerra e ai soldati – spiega Anna Malienko, coordinatrice dell’assistenza umanitaria per lo Spazio dei veterani della Regione di Dnipro – qui nella nostra sede raccogliamo cibo, indumenti, coperte per chi ha bisogno e realizziamo reti mimetiche per gli accampamenti di chi sta al fronte. Inoltre cerchiamo di offrire un supporto psicologico a chi torna a casa dopo aver combattuto e spesso soffre di disturbi del comportamento e fatica a riadattarsi a una vita civile.”
Anna ha un figlio al fronte, e ha trovato nell’assistenza umanitaria il suo modo per sentirlo vicino anche quando non riceve notizie per tempi che sembrano lunghissimi. “Aiutare gli altri è come essere al suo fianco – dice – e riaccogliere i veterani in progetti di reinserimento sociale è un modo per pensare che un domani anche lui avrà una comunità in grado di supportarlo.”
L’associazione raccoglie volontari di ogni età, dagli adolescenti alle donne anziane, che partecipano alle attività, alle raccolte fondi, alla distribuzione di pasti e beni di prima necessità per gli sfollati. Poi ci sono gli specialisti che si prendono cura degli orfani di guerra e delle famiglie che hanno perso un parente nel conflitto.
L’ultimo attacco di droni russi a Dnipro, di pochi giorni fa, ha ucciso tre persone e ne ha ferite una decina. “Non ci si abitua mai a tutto questo – dice Olena – che nella storia della città cerca conforto: su questo fiume e su queste pietre abbiamo fondato le nostre radici, e oggi le persone stanno riscoprendo le proprie origini, hanno voglia di farlo. Senza la guerra forse non avremmo avuto lo stesso processo. Siamo un paese giovane, ma abbiamo sviluppato un senso di appartenenza allo Stato molto forte.”
La storia dell’Ucraina è stata raccolta nel museo cittadino, che si è recentemente arricchito di una nuova sezione che racconta la guerra in corso. Ci sono i rottami di alcuni mezzi militari russi, i cartelli stradali delle città oggi sotto occupazione, come Mariupol, Melitopol, Berdiansk, Donetsk e Luhansk, le foto dei militari morti al fronte, collezioni di schegge, cassette di munizioni, divise e bandiere. In una delle sale viene proiettato un documentario che raccoglie testimonianze e immagini dal fronte. Una scolaresca ha appena finito la sua visita guidata all’interno.
“Sono cresciuta ai tempi dell’Unione Sovietica e mai avrei pensato che dopo l’indipendenza avremmo dovuto affrontare una guerra contro la Russia – dice Olena – è una cosa che mi sconvolge perché veniamo dalla stessa storia. Ma la frattura che si sta creando oggi non credo sarà possibile da sanare in futuro. In questi ultimi mesi ho visto diverse persone tornare a Dnipro, e altri conoscenti vorrebbero farlo. In fondo non si può stare lontani per sempre, e la sicurezza finisce per non essere più un deterrente sufficiente.”
Anche i dati dell’ultima ricerca dell’Unhcr sulla speranza di ritorno degli sfollati confermano le parole di Olena: rispetto a sei mesi fa, la quota di “idp, internally displaced people” che spera di poter fare ritorno a casa nel prossimo anno è rimasta costante (69%), mentre si sono registrate differenze minime fra coloro che sono indecisi (11% contro 12%) e chi dichiara di non avere speranze di tornare (16% contro 15%). L’intenzione di ritorno varia anche in base alla vicinanza tra i luoghi di sfollamento e quelli di origine, e coloro che sono rimasti nella stessa regione possono sperare di riavvicinarsi a casa con più “facilità”.
Fra i rifugiati che hanno lasciato il paese, invece, la pianificazione di un possibile ritorno è in calo: se nel 2023 ci sperava il 77% dei 4.3 milioni di ucraini che oggi vivono in paesi dell’Unione Europea, nel 2024 la percentuale è scesa al 65%.
I paesi Ue che continuano ad ospitare il maggior numero di cittadini provenienti dall’Ucraina sono la Germania con 1.177.800 persone, la Polonia con 994.790 e la Repubblica Ceca con 397.750; il primo paese extra Ue è il Regno Unito con 254.000. Seguono la Spagna con 231.500 rifugiati, la Romania con 182.200 e l’Italia con 163.630.