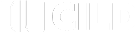1. Il gestore dei centri in Albania licenzia gli operatori
Nonostante il governo intenda proseguire con il piano Albania, l’ente gestore ha licenziato gran parte dello staff.
“[…] Un centinaio di lavoratori dell’ente gestore hanno ricevuto una lettera – che Domani ha potuto vedere – dal loro datore di lavoro: La informiamo che a causa di una serie di pronunce giudiziarie contraddittorie e non conformi agli orientamenti della Corte di Cassazione italiana, nonché dell’impossibilità momentanea di accogliere nuovi flussi di migranti, siamo costretti a sospendere temporaneamente il nostro servizio, si legge. La prefettura di Roma aveva aggiudicato a maggio 2024 l’affidamento alla cooperativa, un colosso già noto nel settore, mesi prima dell’effettiva apertura delle strutture di Shengjin e Gjader, i centri di identificazione e trattenimento destinate a persone salvate dalle autorità italiane in acque internazionali e provenienti da paesi considerati sicuri. E quindi sottoponibili alle procedure accelerate di frontiera. Centri che in quattro mesi sono stati operativi per un totale di circa due settimane”, scrive la giornalista Marika Ikonomu su Domani.
Ricordiamo che, “finora i giudici non hanno convalidato i trattenimenti dei migranti perché credono che sarebbero in contrasto con le norme europee. In base agli accordi, in Albania dovrebbero andare solo i migranti provenienti da “paesi di origine sicuri”, ossia che rispettano i diritti e le libertà democratiche. Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha però stabilito che i paesi “sicuri” debbano esserlo per tutte le persone che ci vivono e su tutto il territorio, una definizione che secondo i giudici non si può applicare ai luoghi di origine dei migranti mandati in Albania, tra cui principalmente l’Egitto e il Bangladesh (la definizione che il governo italiano dà di “paesi sicuri”, peraltro, è molto problematica e viene estesa anche a paesi che non sono davvero sicuri, come la Tunisia e la Nigeria)”, riporta Il Post.
2. Inizia il processo per la morte di Moussa Balde
Il 12 febbraio è iniziato il processo per il caso di Moussa Balde, il giovane guineano che si è tolto la vita nel 2021 nel Cpr di Torino. Il responsabile del Cpr e un medico del centro sono stati accusati di omicidio colposo.
“Balde, 23 anni originario della Guinea, era stato prima vittima di un’aggressione da parte di tre uomini a Ventimiglia, dunque arrestato perché privo di documenti e condotto nella struttura detentiva torinese. Qui era stato confinato in isolamento, dove poi si è tolto la vita. È un processo importante ma parziale, perché manca tutta la parte sulla gestione istituzionale del Cpr, ha commentato [Gianluca] Vitale, legale della famiglia.”, riporta Giansandro Merli su Il Manifesto. E ancora: “sono chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo Annalisa Spataro, all’epoca direttrice del centro per conto della società Gepsa che aveva vinto l’appalto, e Fulvio Pitanti, il medico che dispose l’isolamento di Balde nel cosiddetto “Ospedaletto” del Cpr di Corso Brunelleschi”.
“Lo aspettavo a casa, erano le 19 e gli dissi di tornare, che il cibo era pronto. Ma lui aveva già previsto di partire per l’Europa senza dirci niente. Non è mai più tornato a cena: è morto nel Cpr. Parla con un filo di voce Djenabou, la mamma di Moussa Balde. Eppure il suo appello rimbomba nella stanza al pian terreno della Fabbrica delle “e” (sede del Gruppo Abele): Chiedo giustizia e verità per mio figlio. E voglio che non succeda più”, si legge su La Stampa.
3. I e le minori migranti non si sentono al sicuro in Italia
L’Unicef nel suo nuovo report “La nostra voce conta” ha evidenziato che il 32% dei minori non accompagnati e dei giovani rifugiati e migranti che vivono in Italia non si sente sicuro.
“Un/a rispondente su tre dichiara di evitare certi luoghi per paura di aggressioni o discriminazioni, con una percentuale ancora più alta tra le ragazze. Il genere, il colore della pelle e la religione sono tra i principali fattori che alimentano questo senso di insicurezza. Proprio il rischio di discriminazione resta una barriera importante. Quasi la metà dei partecipanti al sondaggio percepisce atteggiamenti di sospetto e paura nei propri confronti, contro solo un 18% che riscontra invece atteggiamenti empatici. Sono infatti riportati con frequenza episodi di discriminazione legati al colore della pelle (39%) o alla religione (6%)”, si legge nel rapporto. E ancora: “Colpiscono anche i dati sul benessere psicosociale e sulla salute mentale. 6 su 10 dei/delle giovani rispondenti ha dichiarato che il percorso di accoglienza ha avuto un impatto negativo sulla propria salute mentale. Molte e molti affrontano ansia, stress e un senso di incertezza, spesso aggravati da barriere linguistiche, difficoltà economiche e paura del giudizio”.
Infine: “sfide anche sul campo dell’istruzione. Il 31% dei giovani non frequenta alcun percorso educativo e chi riesce a iscriversi spesso deve affrontare lunghi tempi di attesa. Inoltre, il 47% degli intervistati ha iniziato a studiare l’italiano solo dopo due mesi dall’arrivo, un ritardo che ha ritardato ulteriormente il processo di inclusione sociale”.
4. Donne migranti vulnerabili alla frontiera italo-francese
Negli ultimi anni, la società civile ha acquisito un ruolo fondamentale per rispondere ai bisogni sanitari delle donne migranti che transitano sul confine italo-francese.
“Molte Ong si sono affermate come attori chiave nella promozione del benessere delle persone più vulnerabili, fornendo risposte laddove le istituzioni non riescono, o non vogliono, intervenire”, scrive la studiosa Alessia Borromeo su Secondo Welfare. “Il ruolo delle Ong al confine risulta […] duplice: sono fornitrici di servizi e di intermediazione. Al confine italo-francese, le Ong contribuiscono infatti all’empowerment delle donne vulnerabili tramite la diffusione di informazioni sui rischi legati al territorio, orientamento ai servizi disponibili sia in territorio italiano sia a livello europeo oltre a fornire informazioni specifiche per le donne sui servizi presenti nel paese di destinazione. Inoltre, rispondono ai bisogni materiali delle persone in transito, offrendo cibo, vestiti, e un luogo sicuro dove potersi lavare e riposare, e forniscono, ad esempio, prestazioni sanitarie facilmente accessibili garantendo la fruibilità dei servizi per la salute sessuale, riproduttiva, materna e psicologica”.
E ancora: “a Ventimiglia, il punto di ritrovo per i migranti è il centro Caritas che ospita diverse organizzazioni non governative tra cui Caritas Intemelia, Diaconia Valdese, WeWorld, Medici del Mondo, Save the Children. Al momento, l’unico progetto dedicato ai bisogni legati alla femminilità di giovani ragazze e donne con un focus specifico sulla violenza di genere, i rischi legati ad un passato o un presente di tratta e rischi di re-trafficking è il Women and Girls’ Friendly Space, parte dello Spazio Sicuro gestito da Caritas e Save the Children”.
5. Il securitarismo europeo non funziona
I leader europei sembrano aver perso interesse in qualsiasi accenno di approccio razionale alla politica migratoria. L’Europa sta sprecando la possibilità di gestire l’immigrazione irregolare in modo più sicuro, più ordinato e più umano.
“I politici centristi europei sono diventati visibilmente silenziosi riguardo alla creazione di percorsi legali per i rifugiati e i richiedenti asilo che vogliono raggiungere il continente, o all’attuazione di politiche basate su prove concrete per gestire la migrazione in modi che potrebbero produrre risultati migliori sia per le persone in movimento sia per i paesi che intendono raggiungere. Al contrario, nelle parole e nei fatti, stanno seguendo i populisti di destra come l’ungherese Victor Orbán e l’italiana Giorgia Meloni, e stanno cadendo nella trappola della deterrenza all’immigrazione: puntando sull’idea che l’immigrazione irregolare sia meglio controllata dalla forza fisica e preventiva dello Stato, stanno alimentando aspettative pubbliche che non saranno in grado di soddisfare”, scrivono gli esperti senior per la migrazione della Fonfazione Robert Bosch Jessica Bither e Hannes Einsporn sul New Humanitarian. E ancora: “le narrazioni sulla deterrenza all’immigrazione gonfiano anche il problema dell’immigrazione irregolare. È vero che 385.445 persone (molte delle quali richiedevano asilo) sono entrate in Ue irregolarmente nel 2023, il numero più alto dal 2017. Ma è difficile vedere come tali numeri possano minacciare una regione con 450 milioni di abitanti, che ha permesso a 3.741.015 cittadini extra-UE di stabilirsi legalmente nello stesso anno. La realtà è che gli ingressi irregolari rappresentano una piccola frazione dell’immigrazione nell’UE”, come ama sottolineare anche la Commissione europea.
Infine: “devono passare dalla deterrenza delle migrazioni con tutti gli strumenti dello Stato alla gestione delle migrazioni con strumenti più flessibili e avvalendosi dell’aiuto di organizzazioni che vadano oltre le burocrazie tradizionali: gruppi della società civile, città, datori di lavoro e gli stessi migranti e rifugiati. Un passo importante è creare più percorsi legali per i richiedenti asilo e i migranti per raggiungere l’Ue”.
6. Respinti e picchiati: l’Ue continua a violare i diritti fondamentali
Un nuovo rapporto della ONG fiamminga di solidarietà internazionale 11.11.11, basato su ricerche condotte con organizzazioni per i diritti umani in Ungheria, Bulgaria, Croazia e altri paesi, rivela che nel 2024 si sono verificati 120.457 respingimenti illegali. Molti di questi hanno comportato violenza, con persone migranti a cui è stato negato l’accesso alle procedure di asilo.
“La Bulgaria ha registrato il numero più alto di respingimenti, con 52.534 casi. Il rapporto evidenzia violenze diffuse, tra cui percosse, uso di cani poliziotto e perquisizioni corporali forzate. Uomini, donne e bambini, anche quelli in gravi condizioni mediche, sarebbero stati derubati e respinti in Turchia, a volte con conseguenze fatali. In Grecia, 14.482 persone sono state respinte in mare, spesso lasciate alla deriva su piccole imbarcazioni di salvataggio in acque turche. Decine non sono sopravvissute. Nel frattempo, in Polonia (13.600 respingimenti), le guardie di frontiera avrebbero utilizzato armi da fuoco, cani da attacco, barre di metallo e catene per intimidire i migranti. I beni, come i telefoni, sono stati sistematicamente distrutti per cancellare le prove degli abusi”, riporta Belga News Agency.
E ancora: “I respingimenti sono illegali sia secondo il diritto europeo che secondo quello internazionali […]”, eppure, “gli stati membri, tra cui Finlandia, Ungheria, Polonia, Lituania e Lettonia, stanno adottando sempre più una legislazione nazionale per legalizzare i respingimenti”.
Foto via Twitter/Zeta Luiss