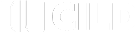Sicuramente l’immagine più iconica è quella che ci riporta al podio dei 200 metri alle Olimpiadi del 1968 a Città del Messico: i due (afro)americani Tommie Smith (primo) e John Carlos (terzo) si presentarono senza scarpe con le calze nere e con un guanto nero rispettivamente infilato nella mano destra del vincitore, e in quella sinistra del compagno. Quando salirono le note dell’inno nazionale statunitense i due alzarono il pugno abbassando contestualmente la testa. Il “black power” era sbarcato alle Olimpiadi. Più tardi Smith disse: “Se ho vinto sono un americano, non un nero americano. Ma se faccio qualcosa di cattivo dicono che sono un negro”.
Non meno eclatante, sullo stesso podio, fu la presa di posizione solidale della medaglia d’argento, l’australiano Peter Norman, che si presentò mostrando la spilla dell’Olympic Project for Human Rights. Norman pagò a caro prezzo l’appoggio ai “colleghi” a tal punto che fu vittima di una campagna del tutto ostile in patria e la sua federazione gli impedì di partecipare alle Olimpiadi di Monaco del 1972, nonostante avesse conseguito i tempi e il diritto all’ammissione. Cadde in depressione e per vedersi riabilitato dovette aspettare gli organizzatori di Sydney 2000 che lo vollero nella loro squadra: fu comunque una vittoria parziale. Norman morì d’infarto nel 2006 e al suo funerale la bara venne sorretta proprio da Smith e da Carlos.

FOTO: Three Proud People / Flickr Creative Commons.
Un altro episodio divenuto celeberrimo ci riporta con la memoria a Berlino 1936, in occasione delle Olimpiadi naziste che la propaganda pensò come vetrina ideale per l’esaltazione della “razza ariana”. La leggenda vuole che il 4 agosto, al termine della gara di salto in lungo vinta da Jesse Owens, Adolf Hitler si sia rifiutato di congratularsi col campione afroamericano che aveva battuto proprio il tedesco, peraltro suo grande amico, Luz Long. Nella sua autobiografia Owens,invece, fornì un’altra versione dell’accaduto: “Il Cancelliere tedesco mi fissò, si alzò e mi salutò agitando la mano. Io feci altrettanto, rispondendo al saluto”. Comunque sia, lo stesso Hitler a causa di discriminazioni nei confronti di altri atleti afroamericani (tra cui l’olimpionico di salto in alto Cornelius Johnson) e non solo fu ammonito dall’allora presidente del CIO Henry de Baillet Latour, per il quale non erano tollerabili distinzioni fra i premiati. Da allora, al di là dei podi, i nazisti decisero di cancellare le celebrazioni pubbliche al termine delle gare. Lo stesso Owens poi dovette subire anche l’umiliazione di non essere ricevuto nemmeno in patria dal “suo” presidente, Franklin Delano Roosevelt.
Tornando a tempi più recenti, una figura che è emersa in tutta la sua forza è sicuramente quella della algerina Hassiba Boulmerka, specialista dei 1500 metri, in grado di vincere la sua gara ai Mondiali di Tokyo del 1991 e soprattutto alle Olimpiadi di Barcellona l’anno seguente. Dopo il successo in Giappone il Gruppo Islamico Armato (una formazione integralista) la condannò a morte perché rea di presentarsi “a tutto il mondo seminuda”. L’atleta che andò a preparare i Giochi in Germania sotto scorta, in una intervista alla BBC ricorda il clima che si respirava prima della sua partenza per l’Europa: “Durante la preghiera del venerdì presso la nostra moschea l’imam disse che non ero musulmana, perché volevo correre in pantaloncini mostrando le mie gambe e le mie braccia. Disse che ero anti-islamica”. A Barcellona non sbagliò nulla e vinse la medaglia d’oro: “E’ stato un trionfo per le donne di tutto il mondo, perché resistano ai loro nemici. E’ questo quello che mi ha reso più orgogliosa”. Hassiba non rinunciò a vivere in Algeria, anche se le minacce alla sua persona non terminarono con le Olimpiadi. Qualche anno dopo al Corriere della Sera rilasciò un’intervista, dalla quale traspariva la piena consapevolezza di essere ormai divenuta un simbolo: “L’emancipazione della donna passa sempre attraverso lo sport (…) Nascondere il corpo di un atleta è un controsenso”.
Un’altra donna che portò alle Olimpiadi le sofferenze non solo di un genere, ma addirittura di un popolo condannato alla guerra, fu Sanaa Abu Bkheet. Palestinese di Haifa, non si avvicinò ai risultati di Hassiba Boulmerka ma la sua presenza ad Atene 2004, nella città culla dello spirito olimpico, fu un bell’esempio di come lo sport può vincere anche sulla guerra. Sanaa, costretta ad allenarsi sulle strade vicino casa o in spiaggia perché l’unica pista di atletica di Gaza venne distrutta da un bombardamento, si riuscì a qualificare solo grazie a un regolamento che prevede per una nazione la partecipazione di almeno due atleti a prescindere dalle loro prestazioni. Superando mille difficoltà logistiche la prima donna di Palestina a partecipare ai Giochi si presentò in pista per le batterie degli 800 metri, arrivando ultima. Ma la sua presenza fu già una vittoria. Una grande vittoria.
L’ultima storia che raccontiamo è quella, forse, più drammatica. Una storia di cui siamo venuti a conoscenza solo nel 2012 dopo le Olimpiadi di Londra. E’ la storia di Samia Yusuf Omar, la più piccola di sei figli di una famiglia di Mogadiscio. Nacque il 30 aprile 1991 e la morte del padre, ucciso nel mercato in cui lavorava, la costrinse a occuparsi dei fratelli mentre la madre andava a lavorare. Allo stesso tempo cominciò ad appassionarsi alla corsa e di conseguenza ad allenarsi. In un Paese dominato da guerre e fondamentalismi per una ragazza come lei si rivelò arduo dedicarsi allo sport e infatti, come raccontò in una intervista alla BBC, in diverse occasioni fu minacciata e persino arrestata: “I somali considerano rovinate le ragazze che praticano sport, musica e che si vestono con abiti trasparenti o pantaloncini”. Nonostante ciò continuò a prepararsi per i 100 metri: nel 2008 fu chiamata ai Campionati Africani, arrivò ultima, ma nonostante questo fu ammessa ai Giochi di Pechino insieme a un altro atleta, come rappresentante della Somalia. Il 19 agosto Samia Yusuf Omar si presentò sulla pista di Pechino per correre i 200 metri: quando le sue avversarie tagliarono il traguardo lei aveva appena terminato la curva e fu accompagnata al traguardo dall’applauso di tutto lo stadio: “E’ stato molto bello che le persone mi abbiano incoraggiata, ma la prossima volta spero di ricevere applausi per una vittoria e non solo perché io debba essere sostenuta”. Il suo rientro in patria la vide costretta a subire nuove intimidazioni e a nascondere la sua vocazione: nel dicembre 2009 con la famiglia si trasferì in un campo profughi a Mogadiscio; dopo la partecipazione ai Campionati Africani a Nairobi l’anno successivo si trasferì in Etiopia, da sola, in cerca di un allenatore. E lo trovò ad Addis Abeba. Non mancarono, però, i problemi perché in assenza dei documenti che le riconoscessero lo status di atleta del Comitato olimpico in asilo politico, non poté utilizzare la pista di atletica per allenarsi. Ma, decisa a rincorrere il proprio sogno olimpico, dopo un mese e mezzo di inattività cominciò a farlo di nascosto. Allenamenti duri, fatti di scatti, corse, sedute in palestra, pesi e tanto sudore. Dopo sei mesi, conscia della impossibilità di essere “regolarizzata”, nell’estate del 2011 a un anno dalle Olimpiadi di Londra, decise di fare il grande passo: intraprendere il viaggio già compiuto dalla sorella (che nel frattempo aveva raggiunto la Finlandia e ottenuto l’asilo politico) verso una nuova vita. Ad attenderla 8000 chilometri dall’Etiopia al Sudan, da lì attraverso il Sahara fino alla Libia e infine via mare verso l’Italia. E oltre. Ma quell’oltre non ci fu mai. Samia Yusuf Omar morì il 2 aprile 2012 nelle acque del Mediterraneo mentre cercava di inseguire il suo sogno. Un sogno a cinque cerchi.
FOTO DI COPERTINA: Maria Alana / Flickr Creative Commons.