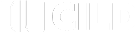“Alcuni bambini qui non hanno un computer a casa. A volte nemmeno un telefono. E allora ti rendi conto che l’esclusione può iniziare anche così, in silenzio, davanti a uno schermo che non si accende.” Karim e Zacharia hanno poco più di vent’anni e trascorrono buona parte delle loro giornate tra cavi, tablet, stampanti 3d e gruppi di bambini che ascoltano, smanettano, scoprono.
Lavorano con Maks, un’associazione che promuove l’inclusione digitale nei quartieri popolari di Bruxelles. La sede è a pochi passi da Molenbeek, e loro ne conoscono ogni angolo. Non sono tecnici, ma animatori digitali: insegnano ai più piccoli come usare uno smartphone in modo critico, come fare una ricerca, come montare un video. E soprattutto, come non restare indietro.
“Sembra una banalità, ma oggi se non sei connesso sei fuori da tutto: scuola, amici, futuro,” dice Karim.
“Non vogliamo solo che sappiano usare le app – aggiunge Zacharia – ma che capiscano cosa c’è dietro. Che diventino attori, non solo consumatori.”
Per entrambi, questo lavoro è anche una risposta. Una forma di riscatto. I loro genitori sono originari del Marocco, ma Karim e Zacharia sono nati e cresciuti proprio a Molenbeek.
“È un posto magico, dove convivono tante culture: marocchini, italiani, tunisini, portoghesi, ognuno fa la sua vita” racconta Karim con un sorriso sottile. “Tutti si sentono liberi qui, è un quartiere multiculturale, e non c’è razzismo”. Poi abbassa lo sguardo: “I media però raccontano tutta un’altra storia…”.
Molenbeek-Saint-Jean è uno dei 19 comuni che compongono la Regione di Bruxelles-Capitale. Un mosaico urbano attraversato da migrazioni, trasformazioni sociali e rigenerazioni lente. Eppure, fuori dal Belgio, e a volte anche dentro, il nome di questo quartiere evoca una sola immagine: quella di un luogo pericoloso, stigmatizzato, associato al terrorismo islamico. Un’etichetta che si è incollata addosso a partire dal 2015, quando emerse che alcuni degli attentatori di Parigi e Bruxelles provenivano proprio da qui.
L’etichetta del terrorismo
Il quartiere ha radici antiche: era un villaggio rurale, poi si è trasformato in centro industriale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’industria ha lasciato il posto soltanto a macerie e disoccupazione. Ed è in quel vuoto che sono arrivati i primi migranti, soprattutto dal Marocco e dalla Turchia.
Il nome di Molenbeek ha cominciato a circolare con insistenza nella stampa internazionale tra il 2015 e il 2016, quando emerse che alcuni degli attentatori coinvolti negli attacchi di Parigi e Bruxelles avevano vissuto o transitato per il quartiere. Bastò questo a trasformare Molenbeek in un simbolo mediatico: l’immagine di un quartiere nel quale l’integrazione non aveva funzionato. Un luogo segnato da disuguaglianze e marginalizzazione, in cui alcune interpretazioni più rigide dell’Islam, correnti salafite e gruppi radicali, avevano trovato spazio, anche se la maggior parte delle moschee era rimasta apolitica.
Non era però la prima volta: già nel 2001 due terroristi avevano soggiornato nel quartiere prima di uccidere il comandante Massud in Afghanistan, due giorni prima degli attentati dell’undici settembre a New York . Nel 2014 Mehdi Nemmouche – radicalizzato in Siria – aveva colpito il Museo Ebraico di Bruxelles. Nei primi mesi del 2015 una cellula jihadista a Verviers fu smantellata e, pochi mesi dopo, passeggeri coraggiosi sventarono un attacco sul treno Thalys Amsterda-Parigi. Infine, l’assalto al supermercato kosher di Parigi legato a Coulibaly, subito dopo la strage di Charlie Hebdo, confermò il filo che legava quegli eventi a Molenbeek. Quel susseguirsi di tragedie fece nascere l’etichetta – ancora oggi ingombrante – di “fucina del terrorismo islamico”.
Crescere sotto lo stigma
Karim a quell’epoca aveva quindici anni. “Ricordo i giorni dopo gli attentati. A scuola ci dicevano di non parlarne. Io continuavo ad andare in moschea con mio padre, e ricordo la polizia, i controlli. Non capivo bene, ma sentivo che c’era qualcosa di diverso. Di grave. Aveva a che fare con il radicalismo, questo sì.” Un’età in cui le domande iniziano a diventare importanti, ma le risposte restano confuse. “Ti senti guardato in un modo che non ti appartiene,” dice oggi. “Come se il tuo quartiere fosse colpevole di qualcosa che non ha scelto”. Per chi come lui cercava solo di vivere una vita normale, il peso dello stigma è rimasto. “All’inizio mi sono sentito strano,” racconta ancora Karim. “Come se fossi colpevole, anche se non avevo fatto niente.”
Anche Zacharia ammette di aver provato gli stessi sentimenti sulla sua pelle. “Quando dici ‘musulmano’, ancora oggi tante persone fanno subito l’associazione con ‘terrorista’, e questo a lungo andare ti logora, devi sempre giustificarti”. Zacharia ha un fisico possente, la barba folta e indossa gli occhiali. “Incarno alla perfezione l’immagine del talebano”, afferma ridendo in modo sarcastico. Ma lo stigma, per i ragazzi di Molenbeek, è andato ben oltre le parole, soprattutto nei mesi successivi agli attentati di Parigi. “Una mia amica – racconta Karim – è stata insultata per strada e quasi investita, solo perché portava il velo.”
È da quella ferita collettiva che nasce oggi il loro impegno. Un attivismo quotidiano, lontano dai riflettori, che aiuta i più piccoli a sentirsi parte di una società che spesso li esclude.
“L’Islam non insegna a uccidere,” ribadisce Karim con voce ferma. “Chi lo fa è stato manipolato. Noi vogliamo solo vivere in pace. E aiutare altri a farlo”.
Nonostante lo stigma, o forse proprio grazie al desiderio di reagire ad esso, da Molenbeek è nata una generazione che racconta la propria identità con voce potente. Basta guardare alla scena artistica del quartiere: una lista lunga e vibrante, che sfida ogni stereotipo.
Dal duo di registi hollywoodiani Adil El Arbi e Billal Fallah, autori tra le altre cose dell’ultimo Bad Boys con Will Smith, alla star dell’hip-hop Zwangere Guy, che ha portato la voce delle banlieue belghe in vetta alle classifiche. Dal coreografo di fama mondiale Wim Vandekeybus, al grande e discusso bestseller Jihad for Love, fino al film cult di Nabil Ben Yadir Les Barons, che racconta con ironia e intelligenza la vita quotidiana dei giovani belgi di origine maghrebina. Una contro-narrazione che prende forma attraverso l’arte, e che rivendica il diritto ad essere complessi, creativi, vivi.
Una memoria attiva
Oggi Molenbeek è casa per quasi 100 mila persone, in gran parte giovani. Il 69% dei residenti ha origini non europee, principalmente marocchine e siriane. La presenza musulmana è stimata tra il 25% e il 40%, fatto quest’ultimo che rende il quartiere uno dei più diversificati della capitale belga. Le sfide di certo non mancano in un luogo in cui il tasso di disoccupazione giovanile tocca la soglia del 40%, portando con sé povertà ed esclusione. Ma allo stesso tempo c’è anche un tessuto sociale molto dinamico, fatto di associazioni, progetti ed idee.
Tra queste c’è il Musée de la Migration, nel cuore del quartiere. Un archivio vivente, un luogo che raccoglie storie di arrivi, di ricordi, di trasformazioni.
“Se non ci fosse stata la migrazione, Bruxelles non sarebbe quella che è,” spiega Loretta Marchi, una delle curatrici del museo. “La città è formata da 184 nazionalità diverse. È il suo punto di forza.”
Nel 2024, in occasione del sessantesimo anniversario degli accordi bilaterali con Marocco e Turchia, il museo ha raccolto oltre cento testimonianze di migranti arrivati negli anni Sessanta. “È stato commovente,” racconta Marchi. “Molti figli non conoscevano la storia dei genitori. Il racconto ha trasformato un percorso individuale in un cammino collettivo”.
Bruxelles 2030: una sfida culturale
Molenbeek è un centro in costante cambiamento. Lo si vede nei murales, nei coworking spuntati tra vecchi magazzini, nei festival culturali che riempiono le piazze in estate. “È un luogo di arrivo e di transito,” racconta Marchi. “C’è un cambiamento continuo, una potenzialità giovanile estrema che mostra nuove facce della città.”
Un ruolo centrale in questo processo lo hanno avuto le associazioni del territorio: doposcuola, centri giovanili, orti urbani, corsi di francese, atelier artistici. Realtà piccole ma vitali, che agiscono come “cuscinetti” tra cittadini e istituzioni.
Ed è proprio su queste basi che si fonda la candidatura di Bruxelles a Capitale Europea della Cultura 2030. Si tratta di una scommessa radicale: partire da Molenbeek per ribaltare le narrazioni tossiche, trasformando la complessità in forza creativa.
“Se non riusciamo a vedere Molenbeek – e le Molenbeek d’Europa – come territori di opportunità, il futuro sarà molto cupo”, avverte Jan Goossens, uno dei promotori del progetto Molenbeek for Brussels 2030. “L’Europa non può costruire un futuro comune se non lo farà insieme alla sua gioventù super-diversa. Non per loro, e nemmeno peggio contro di loro: ma con loro”.
Arte, spazio pubblico e cittadinanza
Goossens non è ingenuo. “La storia dell’immigrazione in Europa è fatta di successi e fallimenti, e le politiche attuali rischiano di seminare nuovi disastri”. Ma un’altra possibilità c’è, ed la cultura. “Se la politica fallisce, se il sistema educativo non riesce a preparare le nuove generazioni, forse possono riuscirci l’arte e la cultura. A patto che si lavori davvero dal basso”, afferma.
Il modello di MolenFest, il festival lanciato nel 2024, è una prova concreta: co-creazione tra artisti e abitanti, uso dello spazio pubblico come terreno d’azione, legame stretto tra arte e obiettivi sociali, educativi, ambientali.
E non solo. Lo scorso 22 Marzo, centinaia di persone si sono ritrovate in una chiesa nel cuore di Molenbeek per celebrare l’Iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno del Ramadan, trasformando la chiesa di Saint-Jean-Baptiste in uno spazio di festa comune che ha unito culture, religioni e sapori.
La strategia è chiara: smettere di vedere Molenbeek come un “problema” e iniziare a riconoscerlo come un laboratorio.
Ripensare il “ghetto”
“Ghetto” è una parola che pesa. E spesso viene usata con leggerezza. Jan Goossens, direttore artistico che lavora a stretto contatto con il quartiere, lo fa notare con lucidità: “Tutti tendiamo a vivere tra simili,” dice. “Lo fanno i marocchini a Molenbeek, ma anche i funzionari europei a Ixelles. Solo che non chiamiamo ‘ghetto’ questi ultimi…”
“Il punto, forse, non è negare i problemi, ma cambiare prospettiva”, incalza Goossens. “Vedere quello che c’è davvero, non solo ciò che ci si aspetta di trovare. Scorgere le reti silenziose di solidarietà, la creatività che resiste, le alleanze locali, la voglia di esserci”.
Come fanno Karim e Zacharia, ogni giorno, a qualche fermata di metro dal centro patinato di Bruxelles. In un’aula di Maks, tra tablet, stampanti 3D e bambini che imparano a non essere solo utenti, ma cittadini digitali. Uscire dai binari del vittimismo. Rompere lo stereotipo. E prendersi la scena.
“Qual è la vera sfida per i giovani di Molenbeek?” chiediamo a Karim. Lui indugia, poi sorride con una punta d’amarezza. “Secondo me, non è neanche una sfida vera e propria. È fidarsi. Fidarsi di sé stessi e del luogo in cui vivono. Perché quando sei giovane, vedi sul telefono, in TV, ovunque: ‘Molenbeek? No, non è un bel posto.’ Allora pensi: ‘Come posso costruirmi un futuro, trovare un lavoro, se appena sentono da dove vengo, dicono: no, non lo voglio’. Ma la verità” – aggiunge – “è che tanti di noi vanno lontano. Lavorano a Londra, a Parigi, in Lussemburgo. La differenza la fa chi crede in sé stesso. Ecco, questa è la sfida più grande: imparare a farlo.”
Immagine di copertina di Romina Vinci.