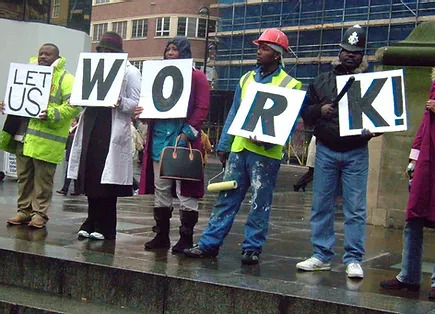In molti paesi d’Europa, le persone che fanno domanda di asilo non possono lavorare per mesi. Per legge. Sembra un dettaglio e invece è un grave problema. Con conseguenze negative nel medio e lungo periodo sia sull’inclusione di questi cittadini stranieri sia sulle economie degli stati che li accolgono. A sostenerlo è lo studio “Lift the Ban? Initial Employment Restrictions and Refugee Labour Market Outcomes”, pubblicato quest’anno da Francesco Fasani, Tommaso Frattini e Luigi Minale.
Gli autori sono arrivati a queste conclusioni studiando, da un lato, le politiche che negli ultimi trent’anni hanno vietato ai richiedenti asilo di lavorare e, dall’altro, i dati relativi all’occupazione dei rifugiati in UE tra il 1985 e il 2012. Quindi, hanno stimato che l’applicazione di questi divieti all’oltre milione di richiedenti asilo arrivati in Europa tra il 2015 e il 2016 avrebbe già causato e potrebbe causare una perdita complessiva di oltre 37 miliardi di euro in otto anni. 4.100 euro all’anno per persona.
L’accesso al mercato del lavoro per i richiedenti asilo è diverso da paese a paese. Nel 2015, ultimo anno preso in considerazione dallo studio, solo Grecia, Norvegia, Portogallo e Svezia non avevamo divieti mentre sostanzialmente tutti gli altri stati europei imponevano restrizioni che andavano dai due ai dodici mesi. Lituania e Irlanda avevano addirittura un divieto illimitato che, però, in questo ultimo caso, è stato dichiarato incostituzionale nel 2017.
Per Francesco Fasani, professore associato alla Queen Mary University di Londra, si tratta di politiche sbagliate. “Che i rifugiati facciano più fatica degli altri immigrati a entrare nel mercato del lavoro è noto. Parte di questa fatica è dettata dalla condizione stessa di rifugiato. Ma una parte è anche causata da questi divieti e il nostro lavoro lo mostra chiaramente”, commenta il ricercatore.
Conseguenze di lungo periodo
Secondo lo studio, se a un richiedente asilo viene vietato di lavorare nei primi mesi di vita nel suo nuovo paese, le probabilità che trovi un’occupazione negli anni successivi al divieto si riducono del 15 per cento. “I mesi iniziali giocano un ruolo chiave nel plasmare le prospettive di integrazione, con conseguenze che durano fino a 10 anni dopo l’arrivo”, spiega Luigi Minale, assistant professor alla Universidad Carlos III di Madrid. Come hanno evidenziato gli autori in un articolo su Vox Eu, la minor partecipazione dei rifugiati al mercato del lavoro incide sul processo di integrazione, che viene rallentato in media di quattro anni.
In pratica, se un richiedente asilo vuole lavorare, non ha senso impedirglielo. Dal punto di vista strettamente economico. Ma anche da quello dell’inclusione. Moussa lo sa bene. Di nazionalità nigerina, è arrivato in Italia dalla Libia diversi anni fa. Poco dopo aver fatto domanda di protezione internazionale, in seguito accolta, è stato assunto prima come lavapiatti e poi come barista. “Lavorare mi ha aiutato con la lingua e non solo. Anche grazie ai colleghi, ho capito piano piano la cultura e la mentalità italiane”, riflette oggi. E poi c’è la questione delle rimesse. Fin dall’inizio Moussa aveva fretta di guadagnare, “per mandare i soldi alla famiglia”.

Foto di Josue Isai Ramos Figueroa via Unsplash
I divieti non tengono conto di questi elementi. Sono nati con altre motivazioni, più o meno esplicite, più o meno nobili. Da una parte, c’è l’idea che i richiedenti asilo abbiano bisogno di aiuto. Dall’altra, ci sono la volontà di tutelare i lavoratori locali da una concorrenza esterna oppure quella di scoraggiare i cosiddetti migranti economici dall’usare il canale della protezione internazionale.
Il punto è che nessuna di queste ragioni, per quanto di segno diverso, pare oggi ancora valida. Innanzitutto perché togliere questi divieti non significa obbligare i richiedenti asilo a lavorare, ma solo dare loro questa possibilità. Poi, spiega Tommaso Frattini, professore all’Università degli Studi di Milano, “perché i richiedenti asilo sono pochi e farli accedere al mercato del lavoro ha un effetto minimo: non aumenta la disoccupazione dei nativi”. Infine, prosegue il ricercatore, “perché la distinzione tra richiedenti asilo «autentici» e migranti di altro tipo si basa su una concezione dell’asilo vecchia e datata”.
Benefici immediati
Rimuovere questi divieti sarebbe quindi una misura dai benefici sostanziali e dai costi nulli. Eppure pochi paesi l’hanno presa. Molti, però, nel corso degli ultimi anni, hanno ridotto la durata dei divieti, seguendo le indicazioni dell’Unione Europea. La questione è stata affrontata con due direttive UE, non vincolanti, che nel 2003 e nel 2013 hanno invitato gli stati membri a non superare prima i dodici e poi i nove mesi di divieto.
L’Italia le ha recepite entrambe e oggi ha un divieto di due mesi, tra i più brevi del continente. Per un richiedente asilo trovare un’occupazione nel nostro Paese rimane complesso, ma almeno su questa singola questione “l’Italia è stata lungimirante”, secondo Frattini. “Credo che i nostri legislatori abbiano considerato il tema poco saliente e quindi non pericoloso”, prosegue. I due cambiamenti alla legge, infatti, sono avvenuti senza suscitare particolari polemiche. “Certo – aggiunge Minale – molto dipende dal contesto. In Germania, dove i numeri dei richiedenti asilo sono più elevati, o in Regno Unito, dove la durata del divieto è più lunga, l’argomento ha ricevuto maggiore attenzione, sia da parte di politici sia da parte di attivisti”.
Anche la pandemia si pensava potesse essere un momento utile per sollevare il tema, soprattutto legandolo alla mancanza di manodopera in alcuni settori. In realtà, c’è stato soprattutto dibattito. Uno dei pochi provvedimenti concreti l’ha presto il Belgio che ha sospeso i suoi quattro mesi di divieto. Secondo diversi organizzazioni che lavorano con gli stranieri nel paese, però, la misura è stata poco sfruttata, per una serie di difficoltà pratiche e perché limitata nel tempo: approvata ad inizio aprile, è rimasta in vigore solo fino alla fine di giugno.
“La nostra impressione è che la finestra di opportunità che si è aperta con l’inizio dell’emergenza Covid-19 si chiuderà presto, quando la crisi economica e sociale si farà sentire”, commenta Minale. A suo giudizio e a quello dei suoi coautori, le motivazioni che spingono a mantenere questi divieti sono solo politiche. “In tempi di crisi – conclude – cambiare misure come queste è molto difficile”.
In copertina: foto di Guilherme Cunha via Unsplash