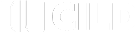Meno di quattro mesi dopo la caduta del regime, una nuova ondata migratoria sta interessando la Siria. Dopo l’eccidio degli alawiti avvenuto fra il 6 e il 9 marzo nella zona occidentale, a Latakia e Tartus, fra le 9 mila e le 16 mila persone hanno già attraversato il confine con il Libano.
Il pretesto che ha innescato questa nuova esplosione di violenza settaria è stata un’imboscata organizzata da alcuni gruppi fedeli all’ex regime contro le forze di sicurezza del nuovo governo provvisorio che presidiavano il territorio di Jableh. Damasco ha inviato i rinforzi, ma alcuni dei gruppi armati arrivati sul posto non si sono limitati a sedare la rivolta, e hanno compiuto un vero e proprio massacro, anche contro civili inermi, giustiziati su base etnica perché appartenenti alla stessa minoranza di Bashar al-Assad.
Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, i morti sono stati oltre 1600, dei quali più di 500 persone non armate, comprese donne e bambini. Da allora il flusso di siriani alawiti che si è spostato verso il nord del Libano, nel governatorato di Akkar, non si è ancora interrotto.
Ad accogliere questi nuovi profughi dall’altra parte del confine sono state soprattutto le comunità alawite dei piccoli centri abitati della zona, come Tal El Bireh e Masaoudiyeh, che hanno gestito il maggior numero di arrivi (rispettivamente 1.557 e 2.331 persone).
In proporzione alla popolazione, inferiore ai 6 milioni di abitanti, il Libano è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, che secondo stime governative raggiungono il milione e mezzo, dei quali 815 mila registrati dall’Unhcr. Solo il 20% dei cittadini provenienti dalla Siria riesce a ottenere una residenza legale, e negli ultimi anni il paese ha aumentato la pressione sui rifugiati affinché tornassero a casa, e la maggior parte dei “ritorni volontari” in Siria sono stati frutto di politiche vessatorie nei confronti di una popolazione vulnerabile. La crisi economica che continua ad affrontare il paese e gli attacchi condotti da Israele sul suo territorio hanno ulteriormente ridotto la sicurezza di tutti gli abitanti e il diritto alla protezione degli stranieri, aumentando il numero di sfollati interni e i bisogni umanitari.
Una crisi umanitaria senza fine
Dal 2011 a oggi, quella siriana è rimasta una delle maggiori crisi umanitarie del mondo, con un numero di rifugiati che ha toccato i 14 milioni, e di sfollati interni che hanno raggiunto i 7,4 milioni.
I siriani vivono oggi in 130 paesi, ma per il 92% si trovano in Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. Oltre il 70% di coloro che sono all’estero vive in condizioni di povertà, con un accesso limitato ai servizi di base, all’istruzione e al lavoro, e solo il 5% ha trovato accoglienza in un campo autorizzato.
In Turchia sono circa 3 milioni, ma negli anni è sempre stato difficile per loro ottenere documenti regolari, tanto che la maggior parte dei siriani soggiorna ancora oggi illegalmente. La situazione è peggiorata dopo l’accordo del 2016 fra la Turchia e l’Unione Europea per il controllo delle frontiere, perché da allora si è registrato anche un numero maggiore di deportazioni forzate, nella fascia di territorio che le forze turche hanno occupato nel nord della Siria.
In Giordania i siriani sono 1,3 milioni, ma solo il 20% di loro vive all’interno di campi profughi istituiti ufficialmente. Sebbene il governo abbia permesso loro l’accesso all’occupazione regolare, gli alti costi dei permessi e dei contributi previdenziali hanno continuato a scoraggiare l’emersione dal lavoro sommerso e quindi anche dal rischio elevato di sfruttamento.
Il dopo Assad: pochi rientri e molte incertezze
La fine di una dittatura durata cinquant’anni ha indotto a credere che la maggior parte dei siriani costretti alla fuga dalla guerra sarebbe tornata a casa. Eppure i numeri dei rientri in patria effettivi sono stati finora molto contenuti, e anche le stime nel medio periodo dell’Unchr sono state riviste al ribasso.
All’inizio di gennaio, ad un mese dalla liberazione, i siriani rientrati da Giordania, Libano e Turchia sono stati complessivamente 115.000, a metà marzo erano all’incirca 300.000. L’Alto Commissariato Onu per i rifugiati aveva pronosticato che nei primi sei mesi del 2025 un milione di persone sarebbero tornate a casa, mentre ora si parla di 600.000 possibili rientri entro il prossimo settembre.
Nonostante i problemi riscontrati nei paesi di accoglienza, il ritorno della maggioranza dei rifugiati in patria resta ancora una speranza difficile da concretizzare: secondo l’Organizzazione Internazionale per le migrazioni, la Siria non è pronta. E il congelamento degli aiuti esteri voluto dagli Stati Uniti di Trump, contestato anche dalla Corte Suprema americana, ha già avuto un impatto fortissimo sulle attività in corso nel paese: secondo l’Ocha, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari, il 90% dei progetti attivi per i siriani ha risentito dei tagli, non solo in Siria dove già il 90% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, ma anche nei paesi limitrofi. Dopo le speranze riposte nel futuro nei primi giorni post liberazione, sono emerse le prime incognite sulle reali possibilità di ricostruzione fisica, sociale ed economica di un paese tutt’alto che pacificato e devastato da 14 anni di conflitto, minato dalla presenza di diverse milizie spesso in contrasto fra loro, oltre a cellule Isis mai del tutto scomparse.
Lo stesso presidente ad interim Al Sharaa, che ha promesso inclusione e si è presentato agli occhi del mondo in una nuova veste da “moderato”, pone non pochi interrogativi sulla possibilità di creare un esecutivo realmente rappresentativo di tutti i siriani, che punti al superamento dei settarismi con un equo sistema di giustizia.
Intenzioni di ritorno: la ricerca regionale dell’Unhcr
Dopo la caduta di Assad l’Unhcr ha condotto una ricerca su un campione di 4.500 siriani oggi residenti in Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto, per capire quali siano le intenzioni di rientro nel medio-lungo periodo. I soggetti coinvolti nell’indagine sono per l’83% adulti fra i 25 e i 59 anni, per il 62% maschi, e nel 41% dei casi appartengono a famiglie monogenitoriali o si prendono cura di una persona non autosufficiente. Fra loro un quarto del totale ha dichiarato che intende tornare in Siria nei prossimi 12 mesi e ricostruire la sua casa, mentre più della metà programma un rientro nei prossimi cinque anni. Il 60% ritiene importante recarsi in Siria per capire le condizioni di persona per poi decidere se tornarci definitivamente oppure no. L’81% degli intervistati riferisce che le sue proprietà sono danneggiate o distrutte, e questo rappresenta il primo ostacolo al rientro.
Le intenzioni di ritorno variano a seconda del paese di accoglienza dei rispondenti: fra coloro che pensano di muoversi nel corso di quest’anno, il 42% si trova in Egitto, mentre la maggioranza di coloro che intendono partire nei prossimi cinque anni vive in Giordania. La speranza di tornare a casa senza una data precisa è alta fra tutti i rifugiati, indipendentemente dalla loro residenza all’estero.
Le differenze possono essere attribuite non solo alle condizioni che si vivono nel paese di accoglienza, ma anche alle differenze fra zone di origine. Ad esempio, la maggior parte dei siriani che vivono in Iraq provengono dal nord est, dove permane una situazione di grande instabilità, soprattutto per gli attacchi turchi contro le postazioni delle forze curde e le infrastrutture, che complicano e rendono insicure anche le vite dei civili.
Molti rifugiati dichiarano di voler tornare da soli se la famiglia è già in Siria oppure se non ne hanno una. Il 75% del campione riferisce di avere le informazioni necessarie per decidere se rientrare oppure no, attraverso i familiari, i social media, i media tradizionali e gli amici.
Il 51% dichiara di avere la casa completamente distrutta, il 30% danneggiata ma comune non abitabile, il 9% intatta e il 7% inabitabile.
Una delle motivazioni che spingerebbe al rientro è l’intenzione di partecipare alla ricostruzione del proprio paese, insieme alle difficoltà di vita incontrate nei paesi di accoglienza.
Le politiche europee
La fine del regime ha spinto alcuni paesi europei a sospendere immediatamente l’elaborazione delle richieste di protezione dei siriani. Paesi come la Germania, l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e la Svezia hanno “congelato” le richieste d’asilo, in attesa di maggiore chiarezza sul futuro del paese, sostenendo che non ci fossero le condizioni per decidere se garantire o meno una protezione.
Una scelta preventiva che appare dettata soprattutto dal timore di ulteriori ondate di profughi, che si tratti di minoranze che temono le nuove forze al potere o persone che rientrano ma non trovano le condizioni per restare. L’orientamento dell’Ue è ancora una volta quello di consolidare economicamente gli accordi con i paesi terzi per la gestione delle frontiere. Appena una settimana dopo la caduta di Assad, la Commissione Europea annunciava già un nuovo stanziamento per la Turchia da un miliardo di euro, per il supporto nella gestione dell’accoglienza. Sulla stessa linea anche il sostegno finanziario per la Siria deciso durante la nona Conferenza di Bruxelles del 17 marzo, quando sono stati raccolti 5,8 miliardi di euro tra prestiti e sovvenzioni, l’80% dei quali provenienti solo dall’Ue e da suoi paesi membri.
Nel 2024, su un totale di 911.960 richieste di protezione internazionale presentate in Ue, 147.965 sono state inoltrate da cittadini siriani, che hanno rappresentato la prima comunità per numero di richiedenti. La Germania è il paese europeo dove vive la maggioranza dei rifugiati provenienti dalla Siria, il 51,9% del totale, e negli anni ha visto una effettiva inclusione. Qui, come pure in altri Stati europei, l’ipotesi di un ritorno in patria potrebbe essere una sfida ben più grande della ricostruzione materiale delle proprie vite in Siria, soprattutto per i più giovani.
In Italia invece, alla fine dello scorso anno, i rifugiati siriani erano 3.500, oltre a 250 richiedenti asilo. Numeri contenuti che si sommano però ai nuovi arrivi via mare, dove i cittadini siriani hanno rappresentato il 17,4% delle 66.000 persone che hanno attraversato il Mediterraneo nel 2024.
Nel riconsiderare la concessione dello status di protezione, tutti gli Stati membri dell’Ue dovrebbero tenere conto non solo del perdurare o meno di eventuali ragioni di persecuzioni individuali, ma anche del percorso fatto nel corso degli anni, perché nel frattempo ogni rifugiato potrebbe anche aver accumulato altri motivi per poter acquisire un permesso di soggiorno, come lo studio o il lavoro, e decidere di restare indipendentemente dalle mutate condizioni nel suo paese di origine.
Il ruolo della Turchia, fra Siria ed Europa
Nessun’altra crisi come quella siriana, nel corso degli ultimi anni, ha ridefinito il ruolo della Turchia nella politica regionale e internazionale, e ne ha condizionato quella interna.
Il paese ha sostenuto a lungo le opposizioni anti Assad, e con la liberazione dal regime ha ora la possibilità di giocare un ruolo determinante nel futuro del paese. Gli obiettivi di Ankara restano gli stessi che aveva anche prima dell’8 dicembre: il controllo delle frontiere, la gestione dei rifugiati, la lotta alle Forze Democratiche siriane a guida curda, accusate di essere vicine al Pkk e pertanto fiancheggiatrici del terrorismo. La prima aspettativa è che la pressione migratoria si allenti: per incoraggiare i rientri volontari, la Turchia sta incentivando le visite brevi in Siria dei rifugiati presenti sul suo territorio, e ha creato un sistema di permessi temporanei valido fino al primo luglio prossimo che consente di attraversare il confine per valutare se ci siano le condizioni per un eventuale ritorno definitivo.
La capacità di influenzare quella che sarà la nuova Siria rende la Turchia un partner strategico sempre più determinante anche per l’Unione Europea, incapace di intervenire direttamente a Damasco, ma determinata a rafforzare le politiche di contenimento dei migranti fuori dalle sue frontiere. Non solo, per Ankara sembra arrivato il momento di giocare un ruolo di mediazione internazionale del quale l’Europa non potrà fare a meno, più vulnerabile e concentrata sulla propria sicurezza dopo l’insediamento di Trump e il riavvicinamento degli Usa alla Russia.