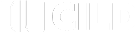1. Dal Cpr in Albania al carcere
Si chiamava Hamid Badoui, era di origine marocchina e si è tolto la vita nel carcere di Torino dopo essere stato rinchiuso per un mese in un Cpr in Albania.
“L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – Asgi – denuncia l’ennesimo dramma del suicidio in carcere di un cittadino straniero, vittima di un sistema repressivo che l’ha visto prima trattenuto in un centro per il rimpatrio perché privo di permesso di soggiorno, poi deportato in Albania nell’ambito dell’operazione propagandistica del governo italiano, successivamente riportato in Italia per effetto della decisione giudiziale di non convalida del trattenimento e infine incarcerato per un reato verosimilmente commesso in un contesto poco chiaro. Hamid Badoui ha posto fine alla sua vita durante l’ultima detenzione e non è difficile immaginare l’insopprimibile stanchezza di vedersi ancora una volta confinato e senza possibilità di via d’uscita”, riporta Domani. E ancora: “Corpi trattenuti in CPR o nelle carceri, poca è la differenza, corpi deportati fuori dal territorio nazionale come prova di forza anche se concretamente inutile, corpi che diventano sempre più strumento di esercizio di un potere diseguale e che non ammette inversioni”, denuncia l’Asgi.
Nel frattempo, sul caso di Badoui è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio: “Sono tanti i punti oscuri sulla vicenda che ha avuto un punto di non ritorno con l’arresto di Hamid il 17 maggio a Torino. Sembra che il 42enne avesse subito una truffa relativa all’acquisto di una scheda sim e avrebbe lui stesso chiesto a un negoziante di chiamare la polizia. All’arrivo degli agenti in Corso Giulio Cesare avrebbe però dato in escandescenze, secondo quanto riportato nel verbale. Un video e alcune immagini dell’arresto diffuse online mostrano i momenti di concitazione dell’arresto, con una piccola folla che chiede alla polizia di “lasciarlo stare. Gli state facendo male”, riporta Torino Today.
2. L’Ue vuole cambiare la Cedu
L’Italia e altri otto Stati membri dell’Ue, tra cui Danimarca e Polonia, hanno pubblicato giovedì una lettera aperta in cui sollecitano un ripensamento dell’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare in materia di immigrazione.
“La lettera che sollecita una revisione è stata resa pubblica in seguito a un incontro a Roma tra Meloni e la prima ministra danese Mette Frederiksen, entrambe con una posizione dura in materia di immigrazione. È stato firmato anche dai leader di Austria, Belgio, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca. Secondo l’agenzia di frontiera dell’Ue Frontex, lo scorso anno gli attraversamenti irregolari delle frontiere nell’Unione Europea sono diminuiti del 38%, attestandosi a 239.000, dopo un picco quasi decennale registrato nel 2023”, riporta Info Migrants. “In attesa di riscrivere le Convenzioni i governi puntano la Corte, l’organo di garanzia di ultima istanza. A questa sono rivolte richieste precise: più potere nazionale per espellere gli stranieri autori di crimini (soprattutto violenti o di droga); più potere di controllo sugli stranieri colpevoli di reato che non possono essere rimpatriati; più potere contro gli Stati ostili che strumentalizzano i migranti. La lettera capovolge completamente la prospettiva: parla di limitazione da parte della Cedu alla sovranità statale, ma quella limitazione è la garanzia di diritti fondamentali che pre-esistono rispetto a Stati e frontiere, afferma [Loredana] Leo [avvocata dell’Asgi]”, scrive il giornalista Giansandro Merli su Il Manifesto.
E ancora: “[Alain] Berset [segretario generale del Consiglio d’Europa] ha accusato i Paesi di indebolire la Corte e la Convenzione: in una società governata dallo stato di diritto, nessuna magistratura dovrebbe subire pressioni politiche. Le istituzioni che tutelano i diritti fondamentali non possono piegarsi ai cicli politici. Se lo facessero, rischieremmo di erodere la stessa stabilità per cui sono state create”, riporta la giornalista Aurélie Pugnet su Euractiv.
3. Espulse dal centro di accoglienza
Si tratta del caso di Fadia, siriana, e Zeineb, tunisina, entrambe rifugiate e ospiti nel Cas (Centro di accoglienza straordinaria) di San Giovanni in Persiceto.
“La prima è commessa al Conad, l’altra addetta alle pulizie in un albergo della Bolognina, almeno finora. A inizio settimana infatti, a seguito dell’ultima circolare della Prefettura ai gestori dei Cas metropolitani per assicurare il turn-over nei centri, è stato notificato loro l’ordine di abbandono della struttura, Entro tre giorni. E l’indicazione di un altro centro di accoglienza dove potersi trasferire. Solo che l’indirizzo è abbastanza lontano. Per Fadia si tratta di Marsala, in provincia di Trapani, per Zeineb di Barletta. E da quello che raccontano senza le informazioni sulle modalità e il mezzo per raggiungerlo”, scrive la giornalista Alessandra Arini su Repubblica. E ancora: “a meno di non trovare una soluzione abitativa in autonomia. Ma a Fadia è stato rifiutato l’affitto di una singola a 380 euro al mese. E in queste ore pensa alla sua bambina, Tacla, disabile e malata oncologica, rimasta nella terra d’origine, in Siria, col papà”.
Infine: “A denunciare la situazione anche il collettivo Plat, che in questi giorni ha raccontato la medesima situazione capitata ai migranti del Cas di Malalbergo. E che attraverso l’avvocata Maria Elena Scavariello prevede un effetto a catena negli altri centri metropolitani. C’è la deliberata volontà di mettere le persone in strada. E di creare insicurezza da sfruttare in campagna elettorale”.
4. La posizione problematica dell’Onu sui rimpatri
Per i paesi dell’Ue che da tempo ormai basano le loro politiche sull’espulsione sistematica delle persone migranti, uno strumento digitale creato dall’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, ovvero l’Oim, è risultato fondamentale. Tuttavia, i critici temono che quest’ultimo stia accelerando procedure di espulsione imperfette, soggette a violazioni dei diritti e carenti di garanzie.
“Un’indagine condotta da dal New Humanitarian suggerisce che il Readmission Case Management System, o Rcms, potrebbe essere stato utilizzato per espellere migranti che avevano un permesso legale per soggiornare nell’Ue, nonché richiedenti asilo che avevano accettato di essere rimpatriati solo per evitare la detenzione. Sebbene questi casi rappresentino una piccola frazione degli allontanamenti volontari e forzati elaborati tramite Rcms, evidenziano il potenziale dello strumento nel facilitare violazioni dei diritti, tra cui espulsioni verso paesi in cui i richiedenti asilo rischiano di subire persecuzioni, il che violerebbe un principio fondamentale del diritto internazionale dei diritti umani noto come non respingimento”, scrivono il giornalista Jacob Goldberg e la giornalista Hamshika Krishnamoorthy sul New Humanitarian. E ancora: “Il ruolo dell’Oim nello sviluppo dell’Rcms si basa su una crescente tendenza degli attori umanitari ad adottare tecnologie che gli stati potrebbero utilizzare per scopi non umanitari. Coincide anche con il coinvolgimento dell’agenzia in altre attività di controllo delle frontiere, come la gestione di un centro di detenzione per migranti americani nella baia di Guantanamo a Cuba, e la firma di un accordo per aiutare gli Stati Uniti a espellere i migranti […]”.
Infine: “Giulio Coppi, responsabile umanitario senior presso l’organizzazione per la difesa dei diritti digitali Access Now, ha affermato che l’Rcms esemplifica l’allontanamento dell’Oim dai principi umanitari per fungere maggiormente da supporto al controllo delle migrazioni su richiesta per i governi”.
5. Perché è ancora importante parlare di cittadinanza e razzismo
Per parlare di cittadinanza occorre un linguaggio che metta in evidenza le storture di un sistema in cui sono presenti disparità tra cittadini/e di serie A e di serie B.
“Come sociologi e sociologhe, occorre dunque prendere le distanze da quello che Abdelmalek Sayad (2002) ha chiamato “pensiero di Stato” che stabilisce chi fa o meno parte della nazione e chi è più o meno meritevole di diritti. L’essere categorizzato/a come migrante sembra livellare tutti gli altri aspetti della vita di una persona e significa essere posizionato/a dai poteri pubblici, dai media e da membri della società come l’Altro/a. Subire un processo di “migrantificazione” (Forkert, Oliveri, Bhattacharyya and Graham 2020, 142) infatti risulta spesso stigmatizzante e discriminatorio. Le figlie e i figli dei/delle migranti in Italia hanno problematizzato fin dagli anni Duemila la categorizzazione delle “seconde generazioni”, contestando la rappresentazione egemonica dell’italianità come cattolica e bianca e avanzando domande di cittadinanza e diritti nella sfera pubblica (Frisina 2007)”, sostiene la sociologa Annalisa Frisina, riportata in un articolo su Melting Pot Europa. E ancora: “sottrarsi alla contrapposizione noi-loro permette di promuovere più facilmente empatia e interesse, perché la storia della battaglia per la riforma della cittadinanza cessa di essere una questione che riguarda solo i migranti e i loro discendenti”.
“Infine: “giovani italiane/i razzializzate/i come non bianche/i attraverso la letteratura e il cinema, il rap e la slam poetry hanno nominato il razzismo sistemico dell’Italia contemporanea mettendolo in relazione alla storia coloniale italiana; inoltre, hanno ri-narrato la storia italiana da una prospettiva transnazionale, legittimando la presenza dei discendenti della schiavitù e della diaspora nera, del colonialismo italiano e della migrazione; infine, non si sono limitati a chiedere la riforma della cittadinanza italiana, ma hanno continuato a chiedere cambiamenti più radicali, come il diritto alla libertà di movimento anche per coloro che provengono dal Sud globale”.
6. I nostri nuovi articoli su Open Migration
La criminalizzazione di persone migranti e di chi presta loro soccorso è ormai una pratica consolidata in tutta l’Ue. Nel nuovo rapporto di Picum “The criminalisation of migration and solidarity in the EU”, ci restituisce un quadro fatto di violazione dei diritti fondamentali e repressione. Ne abbiamo parlato con Silvia Carta, co-autrice del rapporto.