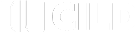La storia di Aisha e di sua figlia Khouloud di 8 anni, detenuti a Lampedusa
Aisha* approda sulle coste di Lampedusa alle due di notte del 15 febbraio 2018, dopo tre giorni di navigazione dalla Tunisia. Si erano persi in mare. Con lei il marito e la figlia Khouloud*, di appena otto anni.
“Eravamo 37 o 38 persone. Abbiamo rischiato di morire, abbiamo incontrato un grande peschereccio e gli abbiamo chiesto di riportarci indietro in Tunisia, ma i pescatori hanno rifiutato e ci siamo persi per tre giorni in cui siamo stati quasi senza mangiare e bere per la preoccupazione. Ci eravamo persi, poi da lontano abbiamo visto una luce e pensando che fosse una barca vicina abbiamo deciso di andare verso la luce. Abbiamo impiegato nove ore per arrivare e alla fine abbiamo scoperto che eravamo a Lampedusa e ci siamo tranquillizzati. La bambina all’arrivo era svenuta e l’hanno messa sull’ambulanza e ci hanno portato al centro.”
Il centro di cui parla Aisha è l’hotspot di Lampedusa, già centro di primo soccorso e accoglienza (Cpsa). Dove resteranno per circa un mese. Con una figlia minore, in mezzo ad uomini adulti. Dove non riusciranno a formalizzare la domanda di protezione internazionale. E dove Aisha racconta di aver subito un tentativo di stupro. Sotto gli occhi sgomenti della figlia minore Khouloud che ha avuto una crisi di panico ed è rimasta priva di sensi per alcune ore. Dove soltanto l’intervento del marito ha evitato conseguenze peggiori. E dove in occasione dell’incendio doloso che ha interessato il centro la notte dell’8 marzo 2018, la bambina ha subito una manganellata all’addome che le ha causato un trauma contusivo al fianco destro.
Poi è stato presentato un ricorso d’urgenza alla Corte Edu, e, dopo circa un mese di detenzione (senza la convalida di un giudice), finalmente la famiglia è stata trasferita ad Agrigento presso una casa famiglia, dove hanno formalizzato la domanda di protezione internazionale.
Ad un mese dalla manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale. Dopo un mese di detenzione senza incontrare un giudice o un avvocato, un tentativo di stupro e una manganellata subita dalla minore.
La storia di Khlaifia, detenuto a Lampedusa e a bordo delle navi Vincent e Audacia
La storia di Aisha e della sua famiglia non è un’eccezione nell’arcipelago dei luoghi della detenzione amministrativa attuata in Italia dall’emergenza Nord Africa del 2011 ad oggi. La detenzione diffusa dei migranti in un centro di primo soccorso, o in un hotspot (come oggi si chiamano) è storia vecchia, a Lampedusa come negli altri luoghi di frontiera italiani.
Già nel caso trattato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo Khalifia (e altri) contro Italia la Corte ha condannato l’Italia per la detenzione senza l’intervento di un giudice e una base legale che hanno subito tre cittadini tunisini arrivati in Italia fra il 16 e il 17 settembre del 2011. I tre ricorrenti furono trattenuti all’interno del centro di primo soccorso e accoglienza (Cpsa) di Contrada Imbriacola, sull’isola di Lampedusa (lo stesso luogo che oggi si chiama hotspot e ha “ospitato” Aisha e la sua famiglia nel 2018), per poi essere trasferiti, a seguito di una rivolta scoppiata all’interno del centro, a bordo delle navi Vincent e Audacia, attraccate nel porto di Palermo. Dove due di loro furono trattenuti fino al 27 settembre e uno fino al 29 settembre. In tali date, a seguito della notifica di decreti di respingimento differito, i ricorrenti furono rimpatriati in Tunisia.
La Grande Camera della Corte europea dei diritti umani, con la sentenza del 15 dicembre del 2016, si è espressa confermando la violazione dell’articolo 5 comma 1, 2 e 4 e dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel dettaglio, la Corte ha rilevato che la privazione della libertà dei tre cittadini stranieri, in assenza di una base normativa chiara e accessibile, non soddisfacesse il principio generale della sicurezza giuridica e fosse contraria all’obiettivo di proteggere l’individuo da decisioni arbitrarie. I decreti di respingimento emessi dalle autorità italiane nei confronti dei tre cittadini non contenevano, infatti, alcun riferimento alla privazione della libertà dei ricorrenti e alle sue ragioni giuridiche e fattuali. Inoltre, il sistema giuridico italiano non offriva agli interessati alcun rimedio giurisdizionale per contestare la legalità della loro privazione della libertà. Infine, non sono state indicate vie di ricorso che i cittadini stranieri avrebbero potuto percorrere per denunciare le condizioni di vita all’interno del centro di prima accoglienza o a bordo delle navi.
La sentenza Khlaifia c. Italia è di importanza cruciale poiché ha sancito in maniera inequivocabile l’arbitrarietà del trattenimento dei cittadini stranieri nei centri di primo soccorso e accoglienza in assenza di una base legale, in assenza di una convalida giurisdizionale e in assenza di rimedi per la verifica della legalità della detenzione.
Anche se oggi i centri di primo soccorso e accoglienza sono di fatto sostituiti dagli hotspot (e integrati, secondo il Decreto Salvini, da non meglio determinate strutture idonee nella disponibilità delle questure), il monito della Corte Edu nella sentenza in commento è da ritenersi valido per tutte le strutture detentive destinate al trattenimento di stranieri.
Il trattenimento negli hotspot e la mancata convalida dell’autorità giudiziaria
I centri Hotspot vengono introdotti in Italia dalla “Roadmap” elaborata dal Governo ai sensi dell’Agenda Europea sull’immigrazione del maggio 2015. In funzione dalla fine del 2015, hanno ricevuto un parziale avallo giuridico con il decreto legge 13/2017 (così detto decreto Minniti).
Il tempo di permanenza in tali strutture, di fatto, può variare da un giorno a settimane e, in casi eccezionali, si è protratto fino a quasi due mesi (nel caso di Aisha, nel 2018, per circa un mese). Le condizioni materiali di vita in tali strutture sono pessime e sono numerose le denunce delle ONG di settore di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali.
Di norma, anche dopo la condanna dell’Italia nel caso Khlaifia e il trattenimento della famiglia di Aisha, il trattenimento in tali strutture non è legittimato dalla convalida di un’autorità giudiziaria.
Anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 132/2018 (conversione in legge del cd decreto Salvini), la convalida del trattenimento in tali strutture è infatti formalmente circoscritta ai soli richiedenti asilo.
Al momento in cui si scrive, tuttavia, non esistono dati sulle (eventuali) convalide giurisdizionali dei trattenimenti disposti ai sensi della legge 132/2018 e vi è fondata ragione di ritenere che non esistano provvedimenti di convalida del trattenimento di richiedenti asilo all’interno degli hotspot, a causa della mancata formalizzazione della domanda di protezione durante il trattenimento degli stessi presso gli hotspot. Sempre come nel caso di Khouloud e i suoi genitori, tra febbraio e marzo 2018. O di Khlaifia e i suoi 2 anonimi ricorrenti, nel settembre del 2011. O di altre decine di migliaia di reietti “trattenuti” o “ospitati” nei “punti di crisi” istituiti nei luoghi di frontiera italiani.
In altre parole, parafrasando lo scrittore Enzo Striano, non è cambiato il resto di niente.
Il progetto Inlimine
Stando all’osservazione diretta degli operatori del Progetto Inlimine, infatti, anche di recente nei centri hotspot continua ad essere attuata una forma di trattenimento de facto in assenza di qualsivoglia ordine adottato dall’autorità competente e convalidato da un’autorità giudiziaria. Tale forma di trattenimento vige generalmente nel periodo che intercorre tra l’ingresso nel centro e il termine delle procedure di identificazione e di rilevamento foto-dattiloscopico. E’ fondamentale chiarire che la privazione della libertà descritta avviene prima che la persona sia classificata come richiedente asilo – attraverso la manifestazione della volontà di chiedere protezione – o come cittadino straniero irregolarmente presente – attraverso la notifica di una decisione di allontanamento. Come nel caso di Aisha e di sua figlia.
Da qui l’attualità della sentenza Khlaifia: di fatto lo Stato italiano sembra continuare a trattenere presso gli hotspot migranti economici e richiedenti asilo senza che vi sia una convalida dell’autorità giudiziaria (come avviene nei Cpr). Inoltre, persiste l’inadempimento italiano in ordine all’assenza di rimedi interni per denunciare maltrattamenti e condizioni di vita all’interno di tali strutture.
Lo stato di (in)attuazione della sentenza Khlaifia
In seguito alla sentenza Khlaifia contro Italia si è aperto il processo di supervisione dell’attuazione della decisione della Corte di fronte al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, organo generalmente deputato al monitoraggio delle misure intraprese dal Governo dello stato oggetto della condanna da parte della Corte Edu.
Al caso Khlaifia è stata assegnata una procedura di supervisione rafforzata, che prevede una serie di revisioni annuali circa le misure adottate, onde evitare il ripetersi di violazioni analoghe a quelle che ne avevano determinato la condanna. L’esecuzione della sentenza e il relativo processo di supervisione appaiono oggi, come osservato, estremamente rilevanti e attuali poiché insistono su temi centrali nella gestione delle migrazioni e nel controllo delle frontiere.
Nel corso di tale processo, a fronte delle richieste del Comitato, il Governo italiano ha presentato tre differenti comunicazioni (settembre 2017, marzo 2018, settembre 2018) e ha infine richiesto, a febbraio 2019, la chiusura della procedura di supervisione, sostenendo (unilateralmente) di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi di violazioni inerenti al trattenimento in hotspot con la legge 132/2018 e, prima ancora, con il decreto legge 13/2017.
Al contrario, come più su accennato, secondo alcune ONG intervenute nel corso del procedimento, di fatto persiste l’assenza di base legale per il trattenimento dei migranti negli hotspot.
In ultimo, la Cild nella comunicazione del febbraio 2020 ha evidenziato altresì il perdurare dell’assenza di rimedi interni per denunciare maltrattamenti o le condizioni di detenzione all’interno di tali strutture.
Conclusioni (parziali, come le soluzioni adottate dal Governo italiano)
Dal 2011 ad oggi decine di migliaia di reietti stranieri (richiedenti asilo e non) sono stati trattenuti in Cpsa, poi divenuti Hotspot, o (non meglio definiti) luoghi idonei al trattenimento senza una base legale o il controllo di un giudice.
Sono cambiati i nomi dei luoghi di privazione della libertà, vi sono state apparenti modifiche normative (come i decreti Minniti e Salvini) ma resta l’assenza di una base legale, di un controllo di un giudice, di un accesso ad un avvocato, della separazione di nuclei familiari con minori da maschi adulti nelle prigioni amministrative.
In conclusione: ferma restando l’esigenza di una revisione critica delle attuali politiche migratorie, la detenzione amministrativa va condotta sui binari del riconoscimento positivo dei diritti fondamentali, a partire dall’introduzione di una normativa di fonte primaria che riconosca chiaramente i diritti delle persone trattenute e rimedi giurisdizionali perché tali diritti non siano solo mere enunciazioni, o diritti di carta.
In definitiva: speriamo che il Comitato dei Ministri non chiuda la supervisione dell’esecuzione della sentenza Khlaifia contro Italia e che le decine di ricorsi pendenti per casi analoghi (compreso quello della famiglia di Aisha e Kholoud) vengano trattati con priorità dalla Corte Edu.
Perché dal 2011 a oggi, nonostante le Fanfare del Governo italiano, in tema di rispetto dei diritti fondamentali degli “ospiti” dei centri di detenzione amministrativa per stranieri non è cambiato il resto di niente.
**I nomi riportati nell’articolo sono di fantasia