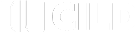S’è da poco fatto buio intorno alla casa di Gelly Kalinikou, ex sindaca di Gavdos, quando un uomo arriva dalla montagna, lungo il percorso che scende fino alla spiaggia di Tripiti. “Chiedeva aiuto e parlava di una donna e un bambino che non riuscivano più a camminare”, racconta la donna, “sono scesa con lui portando cibo e acqua e ho trovato i naufraghi in mezzo al buio, ma non ho mai trovato la donna e il bambino”. È così che le persone sbarcano nell’ultimo lembo di terra europea, in pieno mar Libico, tra Creta a Tobruk: nel silenzio e nel buio.
Una decina di barconi abbandonati lungo la riva, copertoni sgonfi usati come salvagente, vestiti, scarpe, documenti, una cassetta di datteri e la scritta “Maya tamam” – per indicare che l’acqua è potabile – sono sparsi tra i sassi del terreno desertico. I resti della traversata sono l’unica testimonianza dell’arrivo dei migranti in quella che in molti definiscono la “nuova Lampedusa”.
In questo scoglio in mezzo al mare, che conta poco più di 40 abitanti, solo a luglio sono sbarcati tre volte i suoi residenti, tutti partiti dalla Cirenaica.
Creta ha registrato oltre 9.000 arrivi dall’inizio dell’anno, niente a che vedere con i numeri ben più alti che l’isola ha visto in precedenza, ma per il primo ministro Kyriakos Mitsotakis queste cifre sono bastate a giustificare lo “stato di emergenza”.
Dieci anni fa la Grecia era il centro della cosiddetta “crisi dei rifugiati”, con centinaia di migliaia di persone in transito verso l’Europa centrale e settentrionale. Oggi i numeri sono lontani da quelli del 2015, ma bastano poche migliaia di arrivi su isole periferiche come Gavdos e Creta per spingere Atene a bloccare in “via emergenziale” la possibilità di fare richiesta d’asilo. Nel 2015, infatti, la Grecia registrò oltre 800.000 sbarchi, la maggior parte di gente scappava dalla Siria attraverso il Mar Egeo dalla Turchia, a causa della guerra civile e in seguito all’avanzata del sedicente Stato Islamico che prese il controllo di gran parte della Siria centrale e orientale tra il 2013 e il 2015. Successivamente, gli arrivi sono diminuiti significativamente, attestandosi a circa 30.000 nel 2017 e 2018, a seguito dell’accordo tra l’Unione Europea e la Turchia. Nel 2024, gli sbarchi sono stati circa 60.000, con un aumento significativo rispetto ai 48.000 del 2023. Solo nella prima settimana di luglio 2025 gli sbarchi a Creta sono stati quasi duemila, con un aumento del 350% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma sono numeri che restano comunque ben lontani dal picco del 2015.
Il governo di Kyriakos Mitsotakis, tuttavia, ha imboccato da tempo la strada della gestione securitaria con il rafforzamento dei pattugliamenti, la sospensione delle domande d’asilo per tre mesi, il coinvolgimento di Frontex e la collaborazione assidua con la cosiddetta Guardia Costiera Libica. Una linea che marca la distanza dall’approccio, pur caotico, di dieci anni fa, quando le istituzioni elleniche furono costrette ad adattarsi a flussi che apparivano ingestibili.
Oggi il messaggio è preventivo, volto a scoraggiare gli sbarchi, limitare la permanenza delle persone migranti nelle isole, accentrare i trasferimenti nei centri di accoglienza di Creta o sulla terraferma. Si tratta di una politica pensata più per mandare segnali interni ed europei che per rispondere a una reale emergenza numerica, anche perchè niente può fermare i flussi di persone in movimento.
Se nel 2015 Atene era un Paese schiacciato dal peso di un flusso epocale, oggi la Grecia si presenta come bastione dell’Europa fortificata. Ma sulle piccole isole, dove i pescatori e i residenti parlano di impreparazione e disagio, la distanza tra la retorica securitaria e la realtà quotidiana rimane evidente.
La misura presa dal governo ellenico, di fatto, ha cancellato ogni percorso legale: nessuno dei migranti arrivati nel Paese dopo luglio ha potuto avviare una richiesta di protezione internazionale. Ufficialmente queste persone non esistono, né per la Grecia né per l’Unione europea.
A fine Agosto centinaia di profughi approdati in Grecia si trovano intrappolati in un limbo senza diritti. Arrivano dall’Egitto, dalla Siria, dal Pakistan, dal Bangladesh e, sempre più spesso, dal Sudan. A Creta la gestione è affidata a strutture improvvisate, come il capannone espositivo di Chania, oggi trasformato in centro di detenzione informale. Nella stessa città dove sempre ad agosto 2025, ufficiali della Guardia costiera libica fedeli al maresciallo Khalifa Haftar, sono stati allenati dalla Guardia Costiera Ellenica “per rafforzare la cooperazione con la Libia orientale nella gestione dei flussi migratori verso le isole del sud, in particolare Gavdos e Creta”.
Nel centro per migranti di Chania, di fatto divenuto una prigione, non si trovano mediatori, né operatori della Croce Rossa, né rappresentanti dell’UNHCR o di altre agenzie internazionali: soltanto una decina di uomini della Guardia costiera, armati e incaricati di sorvegliare e che cacciano i giornalisti. Secondo fonti locali, tra di loro ci sarebbero anche alcuni degli stessi ufficiali coinvolti nell’inchiesta sul naufragio di Pylos del 2024. La portavoce della Guardia Costiera Ellenica in un’intervista esclusiva condotta con chi scrive ha dichiarato che “non è sua materia”, né l’addestramento della guardia costiera libica da parte di quella ellenica, né cosa facciano gli ufficiali indagati per il naufragio di Pylos.
“Non c’è nessuna organizzazione dentro il campo – racconta Christina Giannari, mediatrice culturale del centro sociale e per migranti Steki Metanaston – Fino a pochi mesi fa cercavamo di segnalare i casi vulnerabili e di indirizzare donne e bambini verso luoghi sicuri ma adesso a noi come a qualsiasi altra organizzazione l’accesso è stato negato e non rimane nessuno a garantire queste procedure”.
Un sistema che contrasta apertamente con la Convenzione di Ginevra del 1951, sottoscritta anche dalla Grecia, che prevede il diritto a chiedere asilo e la protezione dei più fragili.
Il cambiamento politico in Grecia ha accentuato una deriva securitaria. Dal 28 giugno il ministero della Migrazione è guidato da Athanasios Plevris, che nelle sue prime dichiarazioni ha ribadito una linea durissima: “Le deportazioni devono essere a carico dei migranti, altrimenti li costringeremo ad andarsene da soli dal paese. I campi non sono alberghi, la Grecia non è un paradiso ma una prigione”.
Il risultato è che, mentre le procedure restano bloccate e i trasferimenti da Gavdos e da Heraklion e Chania verso Atene o si moltiplicano, i centri si riempiono rapidamente. Le persone migranti recluse da un centro ad un altro non sanno quale sarà il loro futuro almeno fin quando non saranno sbloccate le procedure d’asilo.
“Dopo la nuova legge che dice che i rifugiati vanno direttamente reclusi nei campi le condizioni di questi ultimi sono diventate terribili – spiega ancora Christina Giannari – I campi prima erano ugualmente affollati ma dato che erano così affollati il processo per le richieste l’asilo era molto più veloce perché volevano accelerare e svuotare i campi ma adesso i migranti stanno lì a tempo indefinito, non posso uscire perché non esiste più la procedura d’asilo, e se usissero sarebbo a tutti gli effetti illegalmente sul territorio greco. Noi Ong, volontari e organizzazioni internazionali non sappiamo niente, non ci viene detto niente. Non sappiamo che fine faranno queste persone. Per esempio gli egiziani, che abbiamo sempre seguito noi, prima gli veniva dato immediatamente il foglio di deportazione (ma non venivano di fatto mai deportati), adesso queste persone sono costrette a stare nei campi fino a quando non riapriranno le procedure d’asilo e anche quando riapriranno non sappiamo cosa accadrà, se davvero verranno deportati così come dichiarato dal ministro dell’immigrazione dopo aver vissuto tre mesi in detenzione illegalmente”.
Eppure, nonostante la prospettiva di detenzione e invisibilità, gli sbarchi non si fermano: centinaia di persone continuano a tentare la traversata da Tobruk verso la Grecia, spinte dal desiderio di una vita migliore.