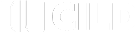Si accendono i motori per il nuovo anno scolastico e con le prime campanelle tornano a farsi vivi gli interrogativi sul volto sempre più multiforme delle nostre classi.
Secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’anno scolastico 2023/2024 gli studenti con cittadinanza non italiana sono stati circa 911mila, in aumento rispetto ai 895mila dell’anno precedente (2022/2023), che a sua volta aveva segnato un incremento rispetto ai 876mila del 2021/2022 e ai 829mila del 2020/2021.
Questi dati mostrano una crescita costante, con un aumento di quasi il 10% dal 2020/2021 al 2023/2024, e l’anno alle porte non sembrerebbe invertire questo trend. La distribuzione territoriale conferma la maggiore concentrazione di studenti con cittadinanza non italiana nel Nord Italia, con Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in testa, e circa il 65% degli alunni stranieri sono “seconde generazioni”, cioè nati in Italia da genitori immigrati.
Questo quadro delineato dall’analisi ministeriale evidenzia come la scuola italiana si trovi oggi a dover affrontare la sfida di costruire un’educazione interculturale e inclusiva, capace di valorizzare la diversità e rompere tabù e stereotipi che spesso ostacolano la crescita collettiva.
In questo scenario che evolve rapidamente, la scuola italiana si confronta con la sfida di costruire un’educazione interculturale e inclusiva, capace di valorizzare le diverse identità e rompere tabù e stereotipi che spesso limitano la crescita collettiva.
Ne abbiamo parlato con Marilena Umuhoza Delli, autrice di Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana. Per un’educazione decoloniale, antirazzista e intersezionale (People, 2023) e del recente Chi ha paura del lupo bianco? C’era una volta il razzismo inconsapevole (Erickson, 2025). Con la sua esperienza diretta e riflessione critica, la scrittrice e attività offre degli spunti per superare pregiudizi e costruire un futuro educativo più consapevole e inclusivo.
Nel libro “Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana” racconta la sua esperienza personale. Cosa significa leggerlo ora, alle porte di un nuovo anno scolastico?
È un saggio scritto per condividere la mia esperienza come formatrice di corsi antirazzismo nelle scuole, come bambina afrodiscendente cresciuta nella scuola italiana degli anni ’80, e ora come madre di una figlia afrodiscendente che va a scuola nel 2025. Il libro vuole offrire linee guida per un approccio antirazzista, decoloniale e intersezionale. Nasce dal desiderio di interrompere il ciclo di dolore che ho vissuto, perché mia figlia e le nuove generazioni di studenti e studentesse razzializzate non vivano la stessa esperienza.
Qual è il ciclo di dolore di cui parla? Che cosa ricorda del suo percorso scolastico?
Il primo giorno fu traumatico. I miei genitori, entrambi insegnanti, mi avevano trasmesso entusiasmo per la scuola. Ero carica e entusiasta, però quando sono entrata in classe, i miei compagni, che erano abbastanza chiassosi, piombarono nel silenzio. E la prima parola che ho sentito è stata “la parola con la N”, una brutta, bruttissima parola. Per tutto l’anno non mi hanno mai chiamato col mio nome, mi escludevano dai giochi e cantavano cori razzisti sul pulmino verso casa, mentre la maestra restava indifferente. Questa esperienza trasformò un momento bello in un dolore profondo. Ora che mia figlia andrà a scuola, voglio fare la mia parte per fermare questo ciclo.
Come appare, oggi, la scuola italiana agli occhi di una bambina di origini africane?
Crescere in Italia come bambina afrodiscendente significa essere immersa in una demonizzazione culturale costante delle persone nere. Cresci con dei libri in cui i protagonisti sono praticamente sempre bianchi e in cui, quando il colore nero appare, viene fortemente demonizzato: il gatto nero porta sfiga, il nero è il colore della strega cattiva, è il colore della rabbia e della paura. Per non parlare del modo in cui vengono rappresentate le persone nere in televisione: il criminale, lo spacciatore, lo schiavo, la badante, la prostituta, mai i protagonisti. E anche il tema dell’immigrazione è trattato in maniera molto negativa, secondo la lente della criminalità e della disperazione. Essere una donna nera italiana implica avere a che fare non solo con il sessismo, ma anche con il razzismo strutturale e il retaggio coloniale, cioè tutti quegli stereotipi che tendono a ipersessualizzare, esoticizzare, inferiorizzare e ridicolizzare i corpi neri femminili come il mio.
Qual è la sfida più grande per la scuola?
La sfida più grande è la narrazione: i libri di testo sono fortemente eurocentrici e biancocentrici. È fondamentale ampliare lo sguardo oltre l’Europa per riflettere la pluralità degli studenti. Raccontare solo storie con protagonisti uomini bianchi rende invisibili molti ragazzi e ragazze, condannandoli alla noia e alla sensazione che le loro storie non contino.
I dati più recenti indicano una presenza crescente di studenti con cittadinanza non italiana. Che impatti ha?
L’aumento degli studenti con cittadinanza non italiana è un dato positivo, specialmente considerando il calo delle nascite in Italia. Si tratta di una trasformazione demografica urgente a cui la scuola deve prepararsi. Purtroppo, la scuola è spesso impreparata a questa realtà. Molti insegnanti si impegnano per introdurre l’antirazzismo, ma spesso si cade nel tokenismo anziché in una reale inclusione.
Che cos’è il tokenismo?
Il tokenismo avviene quando, per esempio, si utilizza uno studente come informante nativo, cioè quando a uno studente di origini africane si chiede “Senti, ma tu vieni da qui, ci racconti un po’ dell’Africa?”. Questo vuol dire dare per scontato che uno studente sappia tutto di un continente solo perché ha quelle origini. Oppure, quando si parla di Africa solo in relazione a temi come la schiavitù o i diritti civili, o quando si presenta un personaggio afrodiscendente in modo esotico e superficiale. Oppure quando si festeggia la giornata dell’antirazzismo senza invece integrarlo in un percorso annuale. Si fa tokenismo anche quando si introduce un autore razzializzato senza puntare sulla qualità. La vera inclusione, invece, richiede un approccio costante e qualitativo.
Porre al centro la narrazione delle migrazioni come costante e non emergenza può essere una svolta?
Sì, è importante considerare le migrazioni come parte continua della storia umana, non un’emergenza legata a criminalità e disperazione. Le migrazioni hanno plasmato l’umanità fin dalle origini, portando all’omogeneizzazione della specie e all’accelerazione dell’organizzazione sociale. Strumenti come l’Africa Migration Report sono essenziali per decostruire miti comuni, dimostrando che il 94% dei migranti africani si sposta per studio o lavoro tramite canali regolari, e la maggior parte delle migrazioni africane avviene tra paesi africani. Solo il 14% dei migranti globali proviene dall’Africa. È cruciale decolonizzare il linguaggio, evitando termini come “clandestino” o “trafficante” per ridurre diffidenze e razzismo. E non bisogna dimenticare che molte migrazioni sono conseguenza di disastri geopolitici legati al colonialismo italiano.
Quali difficoltà incontrano gli studenti stranieri?
Gli studenti razzializzati spesso si trovano a dover fare i conti con le microaggressioni legate al colore della loro pelle, con il razzismo strutturale, con l’invisibilizzazione di persone come loro nei libri e nei mass media in generale, per non parlare degli stereotipi di matrice coloniale che permeano tutto ciò che leggiamo, vediamo o ascoltiamo. Bell Hooks parla di “politiche della vergogna” che umiliano lo studente e di cui un insegnante non può non tener conto.
Nel suo libro parla di educazione decoloniale, antirazzista e intersezionale. Può spiegare cosa significano questi termini e come devono tradursi nella scuola?
L’educazione decoloniale aiuta a identificare e smantellare gli stereotipi coloniali ancora diffusi nella società e nei media, come l’ipersessualizzazione e la ridicolizzazione dei corpi neri. Si basa anche su uno studio approfondito del colonialismo italiano, dalla conquista del Corno d’Africa alle leggi razziali fasciste.
Educazione antirazzista significa acquisire consapevolezza che il razzismo è un sistema in cui viviamo, non solo un problema morale individuale. L’altro termine importante è intersezionale: significa riconoscere e valorizzare le diverse identità di oppressione e discriminazione (razzismo, sessismo, abilismo, LGBTQIA+ fobia, classismo ecc.) . L’intersezionalità prepara a relazionarsi con il mondo in modo empatico e aperto.
Nel suo ultimo libro “Chi ha paura del lupo bianco?” indaga quello che definisce “razzismo inconscio”. Come si rappresenta?
Le nostre infanzie sono state attraversate da lupi neri e uomini neri, minacciosi allo stesso modo. Dalle ninne nanne di uomini neri che ti portano via, alle fiabe di lupi neri a caccia di bambine bianche, il nostro immaginario è colonizzato da stereotipi razzisti. È fondamentale introdurre il tema del razzismo ai bambini fin dalla scuola dell’infanzia, poiché i pregiudizi razziali si sviluppano precocemente (già tra 1 e 3 anni i bambini assorbono il linguaggio degli adulti, e tra 3 e 4 anni iniziano ad escludere, prediligendo i compagni bianchi). Esporre i bambini a storie di amicizie interrazziali può smantellare questi pregiudizi in una sola settimana. Il silenzio sul razzismo, al contrario, lo rafforza, lasciando i bambini in balia di stereotipi negativi veicolati da conversazioni adulte e mass-media. È necessario fornire gli strumenti per affrontare la questione della razza come costrutto sociale e del razzismo fin dall’asilo. Questo libro nasce per fare emergere tutto il razzismo inconsapevole che è in noi. Perché il razzismo non ha nulla a che fare con la moralità o con le singole azioni: il razzismo è un sistema in cui noi tutte e tutti siamo nati e cresciuti, me inclusa. Un sistema che attribuisce risorse, diritti e potere a una categoria di persone, negando lo stesso accesso a tutte le altre. E se siamo persone bianche, comprendere questo privilegio è il primo passo verso la consapevolezza e la costruzione di un percorso antirazzista.
La scuola italiana si sta dunque ampliando alla multiculturalità: sono più i rischi o le opportunità?
Spesso, le persone come me di origine straniera vengono chiamate “seconda generazione” o “nuovi italiani”, e penso che sia sbagliatissimo. Quando ci chiamano “seconda generazione”, mi viene da dire “secondi a chi?”. Quando ci chiamano “nuovi italiani”, mi viene da ridere perché l’Italia, in realtà, è sempre stata multiculturale, fin dall’antichità. Addirittura, c’è stata una dinastia di imperatori romani libici, i Severi, che ha prodotto Caracalla, il quale 1800 anni fa estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero per salvare Roma dal collasso economico. Quindi Caracalla, 1800 anni fa, si dimostrò molto più avanti dei legislatori dell’Italia del 2025. L’Italia è un’identità plurale, portatrice di molte culture in sé. Il rischio è invisibilizzare questa multiculturalità, mentre l’opportunità è valorizzarla alla massima potenza come punto di forza.
Un augurio per il nuovo anno scolastico?
Auguro un anno scolastico antirazzista, decoloniale e intersezionale. Invito docenti e genitori ad ascoltare i giovani con apertura, pronti a mettere in discussione le proprie convinzioni e il razzismo che può esserci dentro ognuno di noi.
Foto via Wikimedia Commons