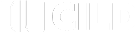Il “ghetto della Pista”, così chiamato perché sorge a ridosso dell’ex aeroporto usato dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi negli anni Novanta come base logistica per le operazioni che partivano da Amendola durante il conflitto in Kosovo, nasce e si sviluppa attorno al Cara, centro di accoglienza per i richiedenti asilo, realizzato nel 2005.
La commistione fra Cara e baraccopoli.
Prima del Cara, su quella base ormai dismessa dell’Aeronautica, era sorto nel 1999 un campo di roulotte per fronteggiare l’emergenza dei profughi kossovari. Fra il 2002 e il 2004, l’intera area era stata poi sottoposta a una serie di lavori di riqualificazione, che nel 2005 avevano portato alla realizzazione di una struttura polifunzionale dedicata sia ai migranti in via di espulsione come Centro di permanenza temporanea (Cpt), con una struttura in muratura, sia ai cittadini del Kosovo con dei moduli abitativi prefabbricati in sostituzione delle vecchie roulotte.
Di fatto il Cpt non è mai entrato in funzione, ma è rimasto un punto di riferimento per l’accoglienza dei richiedenti asilo. Cinque anni dopo, nel 2010, è stata realizzata una nuova zona abitativa composta da ulteriori container nello spazio che separava le due aree originarie, mentre i vecchi moduli, abbandonati poco lontano, sono stati occupati da altri migranti in cerca di un posto dove stare. Pian piano si sono poi aggiunte sempre nuove baracche, costruite con materiali di risulta, che hanno esteso il campo fino a raggiungere le dimensioni di oggi, quando arriva ad ospitare fra le 2 mila e le 5 mila persone a seconda della stagione, dell’andamento della produzione agricola e della necessità di manodopera a basso costo. I varchi aperti nella recinzione del Centro autorizzato hanno messo in comunicazione i due spazi, annullandone i confini.
Vite precarie
Nel campo non c’è acqua corrente, e se d’inverno si rischia la vita per riscaldarsi con mezzi di fortuna, in estate le baracche raggiungono una temperatura di quasi 50 gradi, soprattutto se ricoperte con i teli di plastica. Non ci sono zone verdi, non esistono sistemi fognari, ma c’è un racket per ogni cosa: dall’acquisto delle taniche per fasi una doccia, al costo del trasporto fino ai campi coltivati, detratto dalla paga giornaliera. Per ogni genere di prima necessità si è creato un mercato informale, e oggi nel campo si può trovare di tutto, dagli spacci alimentari alle bancarelle di scarpe e vestiti usati, dalle officine per le biciclette a piccoli caffè. Qui operano anche diversi gruppi criminali, che gestiscono non solo il lavoro agricolo sottopagato ma anche il traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione, e spesso sono proprio le attività illegali a mettere in comunicazione il ghetto con il mondo esterno. Il 12 giugno scorso è morto Ogbodo Ike Chukwu, cittadino nigeriano di 49 anni: ha avuto un malore ed è stato ritrovato senza vita nella sua baracca. È l’ottava vittima di Borgo Mezzanone dall’inizio dell’anno. Le prime cause di morte per i braccianti del ghetto, oltre ai problemi di salute dovuti alle precarie condizioni di vita, alla fatica estrema e alle scarse possibilità di prevenzione e di cura di eventuali patologie, sono gli incendi, che avvengono spesso, soprattutto d’inverno, e gli incidenti stradali.
L’11 settembre del 2024 un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso ha investito e ucciso Tounkara Karamoko, 28 anni, che stava andando a lavorare all’alba, con un altro bracciante, a bordo di uno scooter, a due km dall’insediamento di Borgo Mezzanone. Nel gennaio del 2023, dentro quello stesso campo, sono morti per le esalazioni di monossido di carbonio Ibrahim e Queen, entrambi trentenni del Gambia; prima di loro, nel 2020, anche Ben Ali Mohamed, detto Bayfall, 37enne senegalese, fu ritrovato carbonizzato a seguito di uno dei tanti roghi scoppiati fra lamiere e tavole di legno. Come lo hanno definito gli operatori di Intersos, presenti da anni nell’ex Pista per fornire un supporto medico con la clinica mobile, “Borgo Mezzanone è un binario morto del percorso migratorio, esempio del fallimento delle politiche degli ultimi trent’anni.”
Iniziative dal basso: la Scuola Fatoma
Per contrastare la marginalità, oltre all’azione di organizzazioni consolidate come Intersos, Solidaunia, Medici con l’Africa Cuamm e altre, l’ultima iniziativa è quella di Scuola Fatoma, nata in maniera spontanea dall’idea di un collettivo milanese di videomaker che, dopo aver girato un documentario a Borgo Mezzanone, ha deciso di tornare per lasciare qualcosa di utile ai suoi abitanti.
L’insegnamento della lingua italiana è sembrato una necessità, ma anziché portare i corsi nel ghetto, i giovani del gruppo A Thing by, autori del lungometraggio One day One day, che racconta la vita dei ragazzi della baraccopoli, hanno deciso di portare fuori i suoi abitanti, e di farli interagire con quelli della frazione di Borgo Mezzanone, che nel frattempo possono iscrivere i propri bambini alle lezioni di inglese.Dalle lingue si è passati ai corsi di primo soccorso e di antincendio, per fornire anche strumenti pratici di sopravvivenza. In base ai finanziamenti raccolti, con i biglietti del film o con donazioni libere, si “allunga la vita” della scuola, che ad oggi è garantita fino a gennaio 2026, in attesa di rinnovare ancora una volta la sua data di scadenza.
La riqualificazione che non arriva mai
Da anni Borgo Mezzanone è oggetto di protocolli di intesa, proposte progettuali, documenti sottoscritti da istituzioni locali e nazionali che più volte hanno ribadito la necessità di risanare questo e altri luoghi di marginalità, legati a doppio filo al caporalato, alle criminalità organizzate e al lavoro agricolo.
Il 27 maggio 2016 i Ministeri del Lavoro, degli Interni, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, insieme alle Regioni Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Sicilia e ad una serie di organizzazioni sindacali e del terzo settore, hanno firmato il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “Cura, legalità, uscita dal ghetto”. Un anno dopo, nel Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2017, viene deliberato il Decreto Legge 915 o “Decreto Sud”, che contiene misure per il Mezzogiorno e che all’articolo 16 si concentra sui contesti di marginalità sociale in aree specifiche, fra le quali il Comune di Manfredonia, con la possibilità di istituire uno o più commissari straordinari del Governo “per il superamento delle situazioni di particolare degrado”.
Nel 2018, il 12 gennaio, arriva il protocollo d’intesa siglato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale, la Regione Puglia, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che prevede la realizzazione di un programma per la sicurezza e la legalità attraverso l’utilizzo dei fondi Pon, Programma operativo nazionale “Legalità” 2014 – 2020, con una dotazione finanziaria di 533 milioni di euro per incentivare la coesione sociale e migliorare il sistema di accoglienza. Nel 2020 la Giunta regionale della Puglia ha ribadito, con la Delibera 1570, la necessità di fare tutto il necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti. Infine, il 24 maggio 2021 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, la Prefettura di Foggia, la Regione Puglia e la Provincia di Foggia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la riconversione del Cara di Borgo Mezzanone in foresteria regionale, per il completamento dell’installazione di 100 moduli abitativi prefabbricati e relativi servizi igienici, per un totale di 400 posti letto, e di altri 150 container con servizi per ulteriori 600 posti, oltre alla ristrutturazione degli immobili in muratura già presenti per 324 posti.
Nessun progetto, a oggi, è stato mai avviato.
L’ultimo miraggio: i fondi del Pnrr
Poche settimane fa, il 5 agosto, Flai Cgil Puglia e Foggia hanno organizzato con i braccianti che vivono nella baraccopoli uno sciopero al contrario: con pale e rastrelli hanno cercato di rimettere in sesto il manto stradale dello sterrato che collega l’insediamento alla strada provinciale, denunciando il rischio che i 200 milioni del Pnrr, Piano Nazionale di ripresa e resilienza, previsti per la riqualificazione di questi luoghi di vergogna, compreso Borgo Mezzanone, vadano persi, mentre migliaia di persone continuano a sopravvivere in condizioni estreme, nonostante contribuiscano alla filiera agroalimentare con il proprio lavoro nei terreni del Tavoliere. Il decreto che assegna i fondi, dei quali 54 milioni sono destinati proprio a Borgo Mezzanone, risale al 29 marzo del 2022, e il termine iniziale per la conclusione degli interventi era stato fissato al 30 marzo scorso. Ma dei 37 progetti da finanziare in tutta Italia per risanare aree abitative precarie dove vivono braccianti agricoli di varie nazionalità, solo 17 sarebbero pronti a partire, e nessun cantiere è mai stato aperto. Il rischio è che anche la proroga di 15 mesi, richiesta dal Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi, non sia sufficiente, e la possibilità concreta di migliorare le condizioni di vita di migliaia di lavoratori vada perduta.
La filiera agricola nel foggiano e lo sfruttamento
Nella provincia di Foggia si concentrano 50 mila ettari di coltivazioni ortive su un totale nazionale di 300 mila, con una prevalenza di piantagioni di pomodori, e già questo dato fa capire perché il Tavoliere sia una delle zone agricole dove la manodopera è più richiesta. Secondo il Rapporto Agromafie 2025, la Puglia è la regione italiana con la maggiore presenza di braccianti (quelli registrati sono 190.973, ai quali bisogna poi aggiungere i lavoratori “sommersi”), in particolare nel foggiano (48.377) e nel barese (52.976). L’alta concentrazione di bracciantato va di pari passo con lo sviluppo di un sistema di caporalato e sfruttamento in collegamento diretto con le organizzazioni mafiose, che attingono manodopera dal bacino dei più deboli, bisognosi e ricattabili, ossia i migranti in condizioni di vulnerabilità come quelli che si ritrovano negli insediamenti spontanei.
L’evoluzione di questi ultimi anni, dovuta anche ad un adattamento a seguito dell’aumento dei controlli nei campi e fra le aziende agricole, è stata il passaggio dal lavoro nero a quello “grigio”, dove il lavoratore viene contrattualizzato con poche giornate in busta paga a fronte di un lavoro ben superiore per numero di ore. Per chi vive in un luogo isolato, emarginato dal centro abitato, soggetto al ricatto e in molti casi senza documenti in regola che consentano anche solo di ipotizzare un cambio di vita, luoghi come Borgo Mezzanone diventano tristemente “stabili”.
Non si tratta evidentemente solo di alloggi e servizi, ma di dare risposte a una parte della popolazione che risiede nella Capitanata. Nella sola provincia di Foggia vive un quarto dei cittadini stranieri presenti in tutta la Puglia, circa 35 mila persone che hanno bisogno di soluzioni sull’ottenimento o rinnovo dei documenti e di dignità lavorativa per potersi creare un’alternativa alla fatiscenza di un ghetto. Tutti temi emersi già nel 2023, quando il quotidiano locale L’Attacco.it aveva organizzato un’assemblea pubblica a Borgo Mezzanone, con la partecipazione dei rappresentanti delle comunità che ci vivono, le istituzioni locali e le associazioni del terzo settore. Un dibattito che è stato l’occasione per ripensare ai migranti come parte di una comunità sempre più multiculturale, piuttosto che come eterna emergenza da piazzare nei container, pure nuovi, ma sempre in disparte.